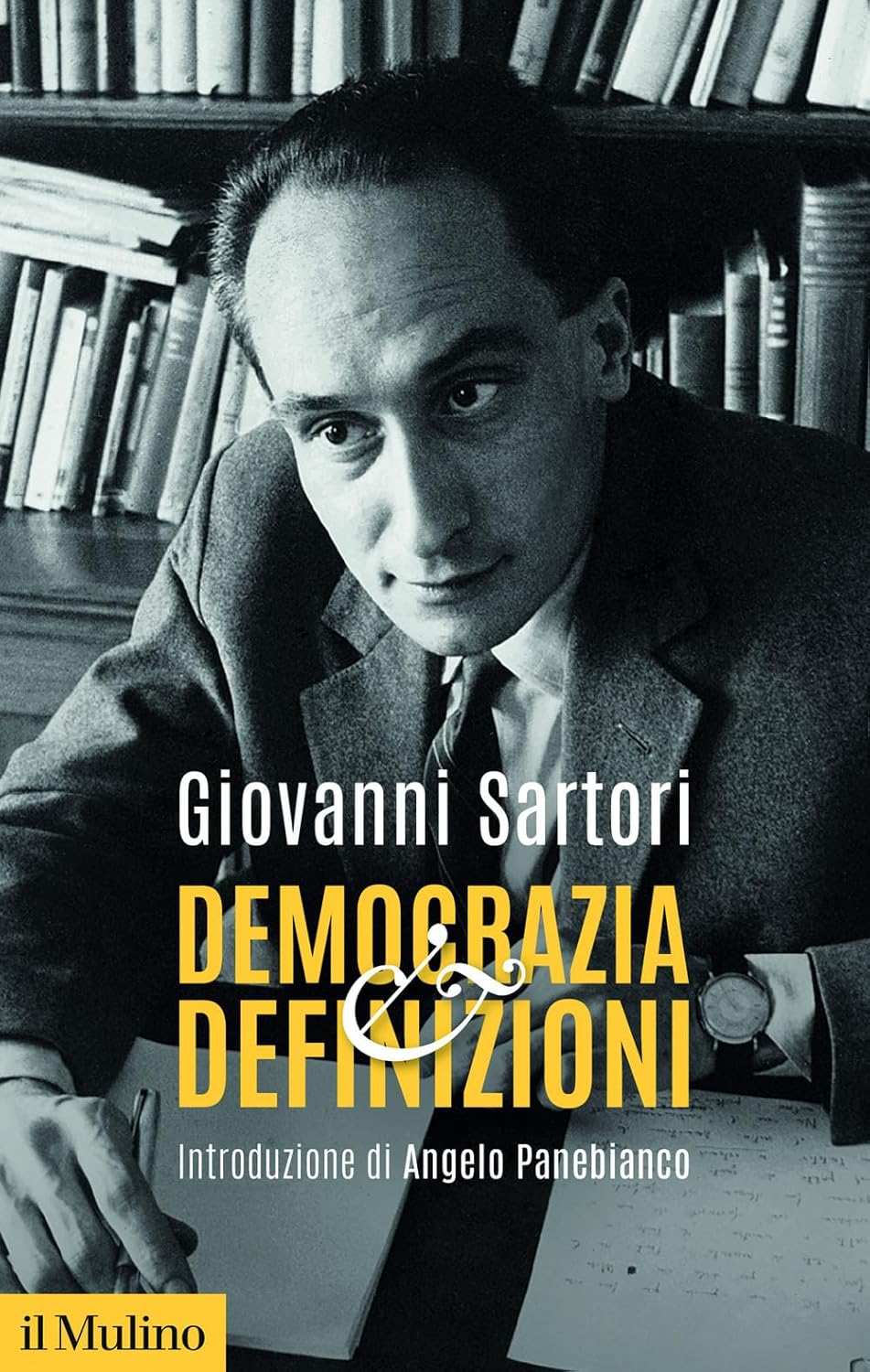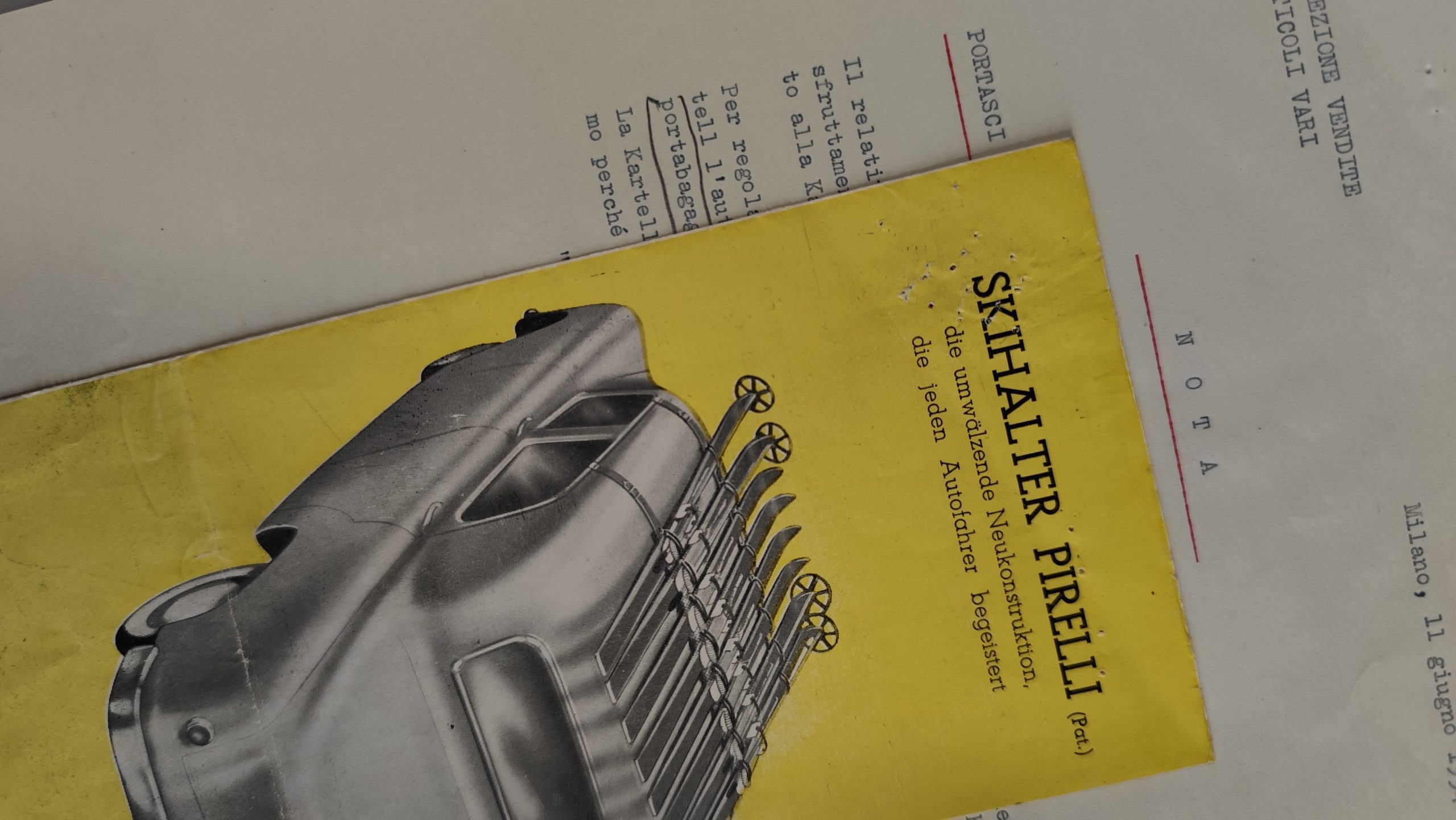Cos’è la qualità della vita? Benessere diffuso, lavoro qualificato e ben retribuito, casa accogliente, servizi efficaci per la salute, la scuola, la cultura e lo sport. E poi una condizione che stimoli l’intraprendenza e l’innovazione, un ambiente civile e rassicurante, la possibilità di progettare per sé e per i propri figli un futuro migliore. Una vita piacevole, in libertà e degna di essere vissuta, insomma. A pensarci bene, un po’ quello che generalmente offre l’Italia, nonostante ombre e contrasti. Anche se, proprio a questo nostro Paese, amiamo attribuire la definizione che Benedetto Croce dava di Napoli, sulla scorta dei viaggiatori europei del Grand Tour: “Un paradiso abitato da diavoli”.
Ma la qualità della vita, in una stagione di drammatiche crisi dei rapporti geopolitici, di fratture negli scambi commerciali internazionali e di clamorosi sconvolgimenti produttivi e sociali provocati dalle tecnologie digitali, non si può leggere solo nel microcosmo della comunità locale, nell’Italia “strapaese”, nella dimensione del “particolare”. Si lega ai grandi temi della libertà, della inclusione sociale e del rafforzamento della democrazia insidiata da demoni autoritari. E dunque al rilancio dell’Europa, territorio che nel corso della seconda metà del Novecento ha elaborato, sperimentato, fatto crescere il modello di un’originale sintesi tra democrazia liberale, economia di mercato e welfare, tra libertà, innovazione e solidarietà.
Qualità della vita, appunto. Per cui vale dunque la pena provare a ragionare non solo su “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, ma anche sui progetti politici e sociali che vale la pena pensare e realizzare. In nome di una migliore condizione umana e civile.
Riguardiamo l’Italia, allora, mettendo da canto stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni. Ci aiutano dati e analisi di indagini recenti, a cominciare dalla classifica annuale de “IlSole24Ore” appunto sulla qualità della vita (1 dicembre), dal Rapporto Censis sullo stato sociale del Paese (5 dicembre) e dai dati dell’Istat sull’economia, l’occupazione e i salari.
Guardiamo meglio, allora. Cominciando con le “mappe del benessere” de “IlSole24Ore” (la prima edizione del censimento risale al 1990). In testa, ci sono Trento, Bolzano e Udine, “il trionfo dell’arco alpino”, titola il quotidiano economico. Poi, Bologna, Bergamo, Treviso, Verona. Milano è ottava (recuperando quattro posizioni sull’anno precedente, anche se scende al penultimo posto per “la sicurezza”), seguita da Padova e Parma e via via continuando, per tutte le 107 province italiane.
Un dato da segnalare: Siena, in classifica generale al 21° posto, risulta invece prima per qualità della vita delle donne: una condizione particolare, su cui è utile che le forze politiche, economiche e sociali facciano un’attenta riflessione, dato che proprio il divario di genere, che si riduce troppo lentamente, è un punto quanto mai negativo della condizione italiana.
In coda all’elenco anche quest’anno c’é Reggio Calabria, preceduta da Siracusa, Crotone e Napoli. Il Sud, come sempre, va male: per trovare la città meridionale meglio collocata in classifica, bisogna arrivare al 39° posto con Cagliari, mentre Bari è al 67° e Palermo al 97°. Roma, la capitale, al 46° (13 posizioni guadagnate sullo scorso anno).
Gli indicatori usati sono 90. E tengono conto di ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, con approfondimenti per genere, età, condizione sociale, etc. Quest’anno le analisi indicano un paese sempre spaccato, sì, ma lentamente in movimento, anche se restano diseguaglianze forti, invecchiamento, gelata demografica, emigrazione dei giovani, bassi salari, disagi. E nelle aree metropolitane, le più dinamiche e attrattive, crescono i problemi sociali, a cominciare da quello della casa.
Nell’opinione europea diffusa, l’Italia è, tutto sommato, un paese in cui si vive bene, grazie anche a un welfare diffuso (soprattutto per la previdenza) e a un sistema sanitario nazionale che, grazie anche al rapporto pubblico-privato, funziona meglio che altrove.
Eppure, il malumore diffuso è ampio, “l’inverno del nostro scontento”, per dirla con il famoso inizio del “Riccardo III” di Shakespeare, trova sempre maggiori sostenitori, il disagio sociale si manifesta con punte di particolare acutezza, soprattutto nel corpo ampio e malcerto di un “ceto medio” che avverte una forte perdita del potere d’acquisto e dunque il peggioramento delle condizioni di vita. “Salari in picchiata: -8.8% rispetto al 2021”, scrive La Stampa (6 dicembre) sulla scorta dei dati dell’Istat: crescono un po’, quest’anno, anche grazie ai contratti di lavoro che si rinnovano, ma non tanto da colmare un gap che ci distanzia dal resto dell’Europa produttiva.
Di questi disagi fanno fede i giudizi dell’annuale Rapporto Censis, il 59°, che fotografa un’Italia sfiduciata, “selvaggia”, che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, mal sopporta la politica attuale, si astiene in misura crescente alle elezioni (alle ultime regionali sono andati alle urne meno di metà degli elettori) e – dato quanto mai inquietante – nel 30% dei casi dichiara di avere fiducia negli “autocrati”, da Putin a Orban, Erdogan, XI JinPing e a Trump. La democrazia, insomma, sta male. La percezione di una cattiva qualità della vita e la perdita di speranze ne mina le fondamenta.
Il leader internazionale preferito è Papa Leone XIV, con il 66,7% dei consensi.
Nel tempo libero, gli italiani fanno moltissimo sesso (il 62,5% dichiara rapporti molto frequenti, anche “virtuali”). Spendono parecchi soldi negli smartphone ma non nei libri. Si lamentano dei bassi redditi. E invecchiano male.
Che succede, insomma? “La politica non sa più ascoltare, guarda solo ai sondaggi. E trascura il ceto medio. Eppure sono proprio queste persone ad avere resistito a paure e declino, a muoversi e potere salvare l’Italia”, commenta Giuseppe De Rita, presidente del Censis, da sempre osservatore critico acutissimo delle evoluzioni e delle involuzioni della nostra situazione sociale (La Stampa, 7 dicembre). Varrebbe la pena che politici e sindacati gli dessero ascolto: è il ceto medio da lavoro dipendente, soprattutto quello industriale, a fare da tessuto connettivo delle nostre industrie e a fornire idee e forza lavoro alle imprese che fanno di tutto per crescere e venire fuori dalla crisi.
Una sintesi acuta è tentata da Chiara Saraceno, sofisticata sociologa, che sottolinea “la sfiducia nell’Europa e nel welfare (il 78,5% non ha fiducia nei servizi sanitari essenziali), in un Paese che vive alla giornata. Pesa la deindustrializzazione, mentre una fascia crescente si impoverisce”.
Cosa servirebbe? Ricostruire fiducia. Nel lavoro, soprattutto tra i giovani. Nella politica. Nella buona amministrazione. Nell’intraprendenza e nell’impresa. Nelle opportunità di costruire un futuro migliore. Anche per affrontare meglio la glaciazione demografica e la “fuga dei cervelli all’estero”. E per attirare capitali e investimenti. Per promuovere le intelligenze creative.
Ha dunque ragione l’Istituto Treccani quando indica in “fiducia” la parola dell’anno (calcolando i clic dei giovani sul suo sito).
Fiducia, come orizzonte personale. E soprattutto politico e professionale.
Fiducia nell’Italia che ce la fa. E soprattutto fiducia nell’Europa, proprio in un momento in cui la Ue vive una profondissima condizione di difficoltà e di crisi.
Ecco un altro punto su cui soffermarsi. Il futuro e le responsabilità dell’Europa. Partendo dal documento sulla National Security Strategy Usa che da alcuni giorni sta scuotendo le opinioni pubbliche internazionali e soprattutto quelle europee. Vi si afferma “il declino economico dell’Europa e la prospettiva reale e ancora più cupa di una cancellazione della civiltà”, messa in crisi “da governi di minoranza instabili che calpestano i principi della democrazia per reprimere l’opposizione” mentre la Ue “mina la libertà politica e la sovranità”. Una sovranità che va riportata agli Stati nazionali. Appunto con la fine della Ue.
È la frattura formalizzata (ma tutt’altro che inattesa) dell’Occidente come lo abbiamo conosciuto nel Novecento delle democrazie liberali. E la presa d’atto della solitudine dell’Europa, innanzitutto sulla propria sicurezza e sulla crisi di quella sintesi, di cui abbiamo parlato all’inizio, tra libertà e welfare, sotto l’ombrello militare protettivo degli Usa e della Nato.
Adesso, proprio per difendere e rilanciare quei valori europei, la Ue “balla da sola”. E deve imparare a sopravvivere. Di fronte a quello che il Corriere della Sera (8 dicembre) definisce “Asse Putin-Trump sull’Europa” (il Cremlino aveva dichiarato la sua piena sintonia con le posizioni del documento Usa), mentre La Stampa (8 dicembre) parla di “Divorzio Atlantico” e il Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno” titola su “L’Europa sotto assedio. Mosca: ‘Siamo con Trump”. E su “L’Europa sotto assedio” titola anche la Repubblica.
Che fare? I commenti dei principali quotidiani italiani, tra sabato e lunedì, sono già stati indicativi sia del disagio sia della necessità di una chiara reazione. Antonio Polito, sul Corriere della Sera, ricorda, citando Mark Twain, che “la notizia sulla morte dell’Europa ci pare grossolanamente esagerata”, anche se la crisi c’è e va affrontata con lungimiranza e senso di responsabilità, contrastando pure la sponda populista filo-Putin e filo-Maga interna all’Europa: una battaglia politica e culturale, difficile e controvento, per combattere la quale, però, l’Europa non è affatto disarmata.
Andrea Malaguti, su La Stampa, invita a “ripartire dalla ricerca di solidarietà dei Paesi che hanno dato vita all’Unione Europea”, senza ambiguità, in modo da pesare di più e in modo autonomo anche all’interno della Nato. E a rilanciare l’Europa, potenza economica e dunque possibile attore internazionale di primo piano, a partire dalla realizzazione del Piano Draghi. E Agnese Pini, sul Quotidiano Nazionale, rileva che è necessario “fare della trasparenza e dello Stato di diritto la nostra identità, perché la forza dell’Europa non è un passato mitico né l’omogeneità etnica, ma la promessa di diritti uguali per tutti, minoranze incluse”. Costruire insomma “un racconto alternativo di civiltà europea”. E “smettere di considerarci come un’appendice del mondo di qualcun altro”.
Europa da riformare. Da rafforzare. Da liberare da burocratismi. E da rilanciare. Senza rompere con gli Usa né pensare di gestire da soli la Nato (non ce lo possiamo permettere, non ne siano ancora tecnologicamente e militarmente in grado). Ma insistendo sulla nostra autonomia (e il rapporto tra Ue e Gran Bretagna in questa prospettiva è essenziale.) Sergio Fabbrini su Il Sole24Ore, parla di “difesa europea nell’epoca post americana”, senza cadere nel militarismo ma continuando a legare sicurezza e democrazia, valori europei e dialogo con tutti gli altri attori internazionali interessati a un equilibrio del mondo diverso dal confronto ruvido tra Usa, Cina e Russia.
È, insomma, una questione di valori. E di libertà. Sicuramente di un nuovo corso della Ue. Ricordando la lezione di Jean Monnet sull’Europa che si rilancia proprio di fronte alle difficoltà.
Così, vale la pena di dare ascolto a uno dei più autorevoli filosofi politici tedeschi, Jurgen Habermas, uno dei padri del pensiero democratico del Novecento: l’Europa è sola, tra espansione cinese e democrazia svuotata da Trump e dunque “un’ulteriore integrazione politica almeno nel cuore dell’Unione Europea non è mai stata così vitale per la nostra sopravvivenza come lo è oggi è mai è sembrata così improbabile” (da una conferenza del 19 novembre alla Fondazione Siemens a Monaco di Baviera). Habermas ha ragione. Come ce l’ha un altro grande pensatore europeo, Michel Foucault: “La libertà non è qualcosa che si possiede, è qualcosa che si pratica”. Una visione liberale e democratica. Una ricostruzione di fiducia.
(foto Getty Images)
Cos’è la qualità della vita? Benessere diffuso, lavoro qualificato e ben retribuito, casa accogliente, servizi efficaci per la salute, la scuola, la cultura e lo sport. E poi una condizione che stimoli l’intraprendenza e l’innovazione, un ambiente civile e rassicurante, la possibilità di progettare per sé e per i propri figli un futuro migliore. Una vita piacevole, in libertà e degna di essere vissuta, insomma. A pensarci bene, un po’ quello che generalmente offre l’Italia, nonostante ombre e contrasti. Anche se, proprio a questo nostro Paese, amiamo attribuire la definizione che Benedetto Croce dava di Napoli, sulla scorta dei viaggiatori europei del Grand Tour: “Un paradiso abitato da diavoli”.
Ma la qualità della vita, in una stagione di drammatiche crisi dei rapporti geopolitici, di fratture negli scambi commerciali internazionali e di clamorosi sconvolgimenti produttivi e sociali provocati dalle tecnologie digitali, non si può leggere solo nel microcosmo della comunità locale, nell’Italia “strapaese”, nella dimensione del “particolare”. Si lega ai grandi temi della libertà, della inclusione sociale e del rafforzamento della democrazia insidiata da demoni autoritari. E dunque al rilancio dell’Europa, territorio che nel corso della seconda metà del Novecento ha elaborato, sperimentato, fatto crescere il modello di un’originale sintesi tra democrazia liberale, economia di mercato e welfare, tra libertà, innovazione e solidarietà.
Qualità della vita, appunto. Per cui vale dunque la pena provare a ragionare non solo su “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”, ma anche sui progetti politici e sociali che vale la pena pensare e realizzare. In nome di una migliore condizione umana e civile.
Riguardiamo l’Italia, allora, mettendo da canto stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni. Ci aiutano dati e analisi di indagini recenti, a cominciare dalla classifica annuale de “IlSole24Ore” appunto sulla qualità della vita (1 dicembre), dal Rapporto Censis sullo stato sociale del Paese (5 dicembre) e dai dati dell’Istat sull’economia, l’occupazione e i salari.
Guardiamo meglio, allora. Cominciando con le “mappe del benessere” de “IlSole24Ore” (la prima edizione del censimento risale al 1990). In testa, ci sono Trento, Bolzano e Udine, “il trionfo dell’arco alpino”, titola il quotidiano economico. Poi, Bologna, Bergamo, Treviso, Verona. Milano è ottava (recuperando quattro posizioni sull’anno precedente, anche se scende al penultimo posto per “la sicurezza”), seguita da Padova e Parma e via via continuando, per tutte le 107 province italiane.
Un dato da segnalare: Siena, in classifica generale al 21° posto, risulta invece prima per qualità della vita delle donne: una condizione particolare, su cui è utile che le forze politiche, economiche e sociali facciano un’attenta riflessione, dato che proprio il divario di genere, che si riduce troppo lentamente, è un punto quanto mai negativo della condizione italiana.
In coda all’elenco anche quest’anno c’é Reggio Calabria, preceduta da Siracusa, Crotone e Napoli. Il Sud, come sempre, va male: per trovare la città meridionale meglio collocata in classifica, bisogna arrivare al 39° posto con Cagliari, mentre Bari è al 67° e Palermo al 97°. Roma, la capitale, al 46° (13 posizioni guadagnate sullo scorso anno).
Gli indicatori usati sono 90. E tengono conto di ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, con approfondimenti per genere, età, condizione sociale, etc. Quest’anno le analisi indicano un paese sempre spaccato, sì, ma lentamente in movimento, anche se restano diseguaglianze forti, invecchiamento, gelata demografica, emigrazione dei giovani, bassi salari, disagi. E nelle aree metropolitane, le più dinamiche e attrattive, crescono i problemi sociali, a cominciare da quello della casa.
Nell’opinione europea diffusa, l’Italia è, tutto sommato, un paese in cui si vive bene, grazie anche a un welfare diffuso (soprattutto per la previdenza) e a un sistema sanitario nazionale che, grazie anche al rapporto pubblico-privato, funziona meglio che altrove.
Eppure, il malumore diffuso è ampio, “l’inverno del nostro scontento”, per dirla con il famoso inizio del “Riccardo III” di Shakespeare, trova sempre maggiori sostenitori, il disagio sociale si manifesta con punte di particolare acutezza, soprattutto nel corpo ampio e malcerto di un “ceto medio” che avverte una forte perdita del potere d’acquisto e dunque il peggioramento delle condizioni di vita. “Salari in picchiata: -8.8% rispetto al 2021”, scrive La Stampa (6 dicembre) sulla scorta dei dati dell’Istat: crescono un po’, quest’anno, anche grazie ai contratti di lavoro che si rinnovano, ma non tanto da colmare un gap che ci distanzia dal resto dell’Europa produttiva.
Di questi disagi fanno fede i giudizi dell’annuale Rapporto Censis, il 59°, che fotografa un’Italia sfiduciata, “selvaggia”, che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, mal sopporta la politica attuale, si astiene in misura crescente alle elezioni (alle ultime regionali sono andati alle urne meno di metà degli elettori) e – dato quanto mai inquietante – nel 30% dei casi dichiara di avere fiducia negli “autocrati”, da Putin a Orban, Erdogan, XI JinPing e a Trump. La democrazia, insomma, sta male. La percezione di una cattiva qualità della vita e la perdita di speranze ne mina le fondamenta.
Il leader internazionale preferito è Papa Leone XIV, con il 66,7% dei consensi.
Nel tempo libero, gli italiani fanno moltissimo sesso (il 62,5% dichiara rapporti molto frequenti, anche “virtuali”). Spendono parecchi soldi negli smartphone ma non nei libri. Si lamentano dei bassi redditi. E invecchiano male.
Che succede, insomma? “La politica non sa più ascoltare, guarda solo ai sondaggi. E trascura il ceto medio. Eppure sono proprio queste persone ad avere resistito a paure e declino, a muoversi e potere salvare l’Italia”, commenta Giuseppe De Rita, presidente del Censis, da sempre osservatore critico acutissimo delle evoluzioni e delle involuzioni della nostra situazione sociale (La Stampa, 7 dicembre). Varrebbe la pena che politici e sindacati gli dessero ascolto: è il ceto medio da lavoro dipendente, soprattutto quello industriale, a fare da tessuto connettivo delle nostre industrie e a fornire idee e forza lavoro alle imprese che fanno di tutto per crescere e venire fuori dalla crisi.
Una sintesi acuta è tentata da Chiara Saraceno, sofisticata sociologa, che sottolinea “la sfiducia nell’Europa e nel welfare (il 78,5% non ha fiducia nei servizi sanitari essenziali), in un Paese che vive alla giornata. Pesa la deindustrializzazione, mentre una fascia crescente si impoverisce”.
Cosa servirebbe? Ricostruire fiducia. Nel lavoro, soprattutto tra i giovani. Nella politica. Nella buona amministrazione. Nell’intraprendenza e nell’impresa. Nelle opportunità di costruire un futuro migliore. Anche per affrontare meglio la glaciazione demografica e la “fuga dei cervelli all’estero”. E per attirare capitali e investimenti. Per promuovere le intelligenze creative.
Ha dunque ragione l’Istituto Treccani quando indica in “fiducia” la parola dell’anno (calcolando i clic dei giovani sul suo sito).
Fiducia, come orizzonte personale. E soprattutto politico e professionale.
Fiducia nell’Italia che ce la fa. E soprattutto fiducia nell’Europa, proprio in un momento in cui la Ue vive una profondissima condizione di difficoltà e di crisi.
Ecco un altro punto su cui soffermarsi. Il futuro e le responsabilità dell’Europa. Partendo dal documento sulla National Security Strategy Usa che da alcuni giorni sta scuotendo le opinioni pubbliche internazionali e soprattutto quelle europee. Vi si afferma “il declino economico dell’Europa e la prospettiva reale e ancora più cupa di una cancellazione della civiltà”, messa in crisi “da governi di minoranza instabili che calpestano i principi della democrazia per reprimere l’opposizione” mentre la Ue “mina la libertà politica e la sovranità”. Una sovranità che va riportata agli Stati nazionali. Appunto con la fine della Ue.
È la frattura formalizzata (ma tutt’altro che inattesa) dell’Occidente come lo abbiamo conosciuto nel Novecento delle democrazie liberali. E la presa d’atto della solitudine dell’Europa, innanzitutto sulla propria sicurezza e sulla crisi di quella sintesi, di cui abbiamo parlato all’inizio, tra libertà e welfare, sotto l’ombrello militare protettivo degli Usa e della Nato.
Adesso, proprio per difendere e rilanciare quei valori europei, la Ue “balla da sola”. E deve imparare a sopravvivere. Di fronte a quello che il Corriere della Sera (8 dicembre) definisce “Asse Putin-Trump sull’Europa” (il Cremlino aveva dichiarato la sua piena sintonia con le posizioni del documento Usa), mentre La Stampa (8 dicembre) parla di “Divorzio Atlantico” e il Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno” titola su “L’Europa sotto assedio. Mosca: ‘Siamo con Trump”. E su “L’Europa sotto assedio” titola anche la Repubblica.
Che fare? I commenti dei principali quotidiani italiani, tra sabato e lunedì, sono già stati indicativi sia del disagio sia della necessità di una chiara reazione. Antonio Polito, sul Corriere della Sera, ricorda, citando Mark Twain, che “la notizia sulla morte dell’Europa ci pare grossolanamente esagerata”, anche se la crisi c’è e va affrontata con lungimiranza e senso di responsabilità, contrastando pure la sponda populista filo-Putin e filo-Maga interna all’Europa: una battaglia politica e culturale, difficile e controvento, per combattere la quale, però, l’Europa non è affatto disarmata.
Andrea Malaguti, su La Stampa, invita a “ripartire dalla ricerca di solidarietà dei Paesi che hanno dato vita all’Unione Europea”, senza ambiguità, in modo da pesare di più e in modo autonomo anche all’interno della Nato. E a rilanciare l’Europa, potenza economica e dunque possibile attore internazionale di primo piano, a partire dalla realizzazione del Piano Draghi. E Agnese Pini, sul Quotidiano Nazionale, rileva che è necessario “fare della trasparenza e dello Stato di diritto la nostra identità, perché la forza dell’Europa non è un passato mitico né l’omogeneità etnica, ma la promessa di diritti uguali per tutti, minoranze incluse”. Costruire insomma “un racconto alternativo di civiltà europea”. E “smettere di considerarci come un’appendice del mondo di qualcun altro”.
Europa da riformare. Da rafforzare. Da liberare da burocratismi. E da rilanciare. Senza rompere con gli Usa né pensare di gestire da soli la Nato (non ce lo possiamo permettere, non ne siano ancora tecnologicamente e militarmente in grado). Ma insistendo sulla nostra autonomia (e il rapporto tra Ue e Gran Bretagna in questa prospettiva è essenziale.) Sergio Fabbrini su Il Sole24Ore, parla di “difesa europea nell’epoca post americana”, senza cadere nel militarismo ma continuando a legare sicurezza e democrazia, valori europei e dialogo con tutti gli altri attori internazionali interessati a un equilibrio del mondo diverso dal confronto ruvido tra Usa, Cina e Russia.
È, insomma, una questione di valori. E di libertà. Sicuramente di un nuovo corso della Ue. Ricordando la lezione di Jean Monnet sull’Europa che si rilancia proprio di fronte alle difficoltà.
Così, vale la pena di dare ascolto a uno dei più autorevoli filosofi politici tedeschi, Jurgen Habermas, uno dei padri del pensiero democratico del Novecento: l’Europa è sola, tra espansione cinese e democrazia svuotata da Trump e dunque “un’ulteriore integrazione politica almeno nel cuore dell’Unione Europea non è mai stata così vitale per la nostra sopravvivenza come lo è oggi è mai è sembrata così improbabile” (da una conferenza del 19 novembre alla Fondazione Siemens a Monaco di Baviera). Habermas ha ragione. Come ce l’ha un altro grande pensatore europeo, Michel Foucault: “La libertà non è qualcosa che si possiede, è qualcosa che si pratica”. Una visione liberale e democratica. Una ricostruzione di fiducia.
(foto Getty Images)