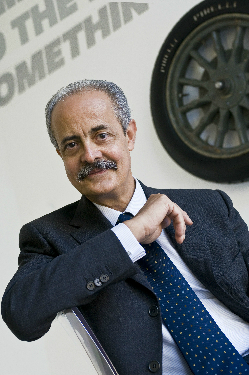Natura d’impresa, non solo il profitto
L’ultima riga del conto economico. In nero, in attivo, cioè. L’imperativo di un’impresa: fare un profitto. Senza il quale non sono possibili salari e stipendi, investimenti, nuovo lavoro, utili per l’imprenditore e i suoi azionisti (“creare valore per gli azionisti”, dice un mantra recente della letteratura aziendale). Certo, il profitto. Non si discute. Si discute, semmai, su come arrivarci (rispettando leggi, regole di mercato, diritti dei lavoratori e di tutti coloro che hanno a che fare con l’impresa, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza, etc.). E su cos’altro deve caratterizzare una buona impresa, oltre l’indispensabile profitto. Ecco una indicazione di Adriano Olivetti, nel suo discorso agli operai di Pozzuoli nel 1955: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita della fabbrica?”. Domande che hanno in sé le proprie risposte, che parlano di valori, dignità, orgoglio del lavoro ben fatto e utile alla comunità. Ecco una parola chiave. Comunità. Nella nuove Edizioni di Comunità (riedizione della casa editrice voluta appunto da Olivetti nel 1946), in un piccolo libro intitolato “Ai lavoratori”, dopo una bella prefazione di Luciano Gallino, si ripubblica sia il discorso di Pozzuoli che quello, analogo, fatto nel 1954 ai dipendenti di Ivrea. Fabbrica e civiltà. Industria e responsabilità generale. Oltre il profitto, appunto. Quasi sessant’anni dopo, le stesse opinioni si ritrovano (forza lenta ma tenace delle buone idee) nelle considerazioni ricavate da due studiosi, Marina Capizzi e Ulderico Capucci, dalle interviste a 60 capi azienda per l’Osservatorio Assolombarda-Bocconi. Si parla di “valore”, ci si chiede “per chi?” e si conclude: “La logica del valore che emerge come nuova via per la competitività si fonda sul concetto della reciprocità del vantaggio con la produzione di benefici per terzi implicati direttamente o indirettamente: la produzione di profitti per sé, per essere duratura, deve essere generata attraverso la produzione di benefici per altri. I benefici non riguardano solo chi acquista e gli azionisti, ma anche gli utilizzatori, i fornitori, i cittadini, etc.”. Profitto di lunga durata, appunto. Nelle mani di tutti gli stakeholders. Buona indicazione, antica e nuova, contro la crisi.






L’ultima riga del conto economico. In nero, in attivo, cioè. L’imperativo di un’impresa: fare un profitto. Senza il quale non sono possibili salari e stipendi, investimenti, nuovo lavoro, utili per l’imprenditore e i suoi azionisti (“creare valore per gli azionisti”, dice un mantra recente della letteratura aziendale). Certo, il profitto. Non si discute. Si discute, semmai, su come arrivarci (rispettando leggi, regole di mercato, diritti dei lavoratori e di tutti coloro che hanno a che fare con l’impresa, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza, etc.). E su cos’altro deve caratterizzare una buona impresa, oltre l’indispensabile profitto. Ecco una indicazione di Adriano Olivetti, nel suo discorso agli operai di Pozzuoli nel 1955: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita della fabbrica?”. Domande che hanno in sé le proprie risposte, che parlano di valori, dignità, orgoglio del lavoro ben fatto e utile alla comunità. Ecco una parola chiave. Comunità. Nella nuove Edizioni di Comunità (riedizione della casa editrice voluta appunto da Olivetti nel 1946), in un piccolo libro intitolato “Ai lavoratori”, dopo una bella prefazione di Luciano Gallino, si ripubblica sia il discorso di Pozzuoli che quello, analogo, fatto nel 1954 ai dipendenti di Ivrea. Fabbrica e civiltà. Industria e responsabilità generale. Oltre il profitto, appunto. Quasi sessant’anni dopo, le stesse opinioni si ritrovano (forza lenta ma tenace delle buone idee) nelle considerazioni ricavate da due studiosi, Marina Capizzi e Ulderico Capucci, dalle interviste a 60 capi azienda per l’Osservatorio Assolombarda-Bocconi. Si parla di “valore”, ci si chiede “per chi?” e si conclude: “La logica del valore che emerge come nuova via per la competitività si fonda sul concetto della reciprocità del vantaggio con la produzione di benefici per terzi implicati direttamente o indirettamente: la produzione di profitti per sé, per essere duratura, deve essere generata attraverso la produzione di benefici per altri. I benefici non riguardano solo chi acquista e gli azionisti, ma anche gli utilizzatori, i fornitori, i cittadini, etc.”. Profitto di lunga durata, appunto. Nelle mani di tutti gli stakeholders. Buona indicazione, antica e nuova, contro la crisi.