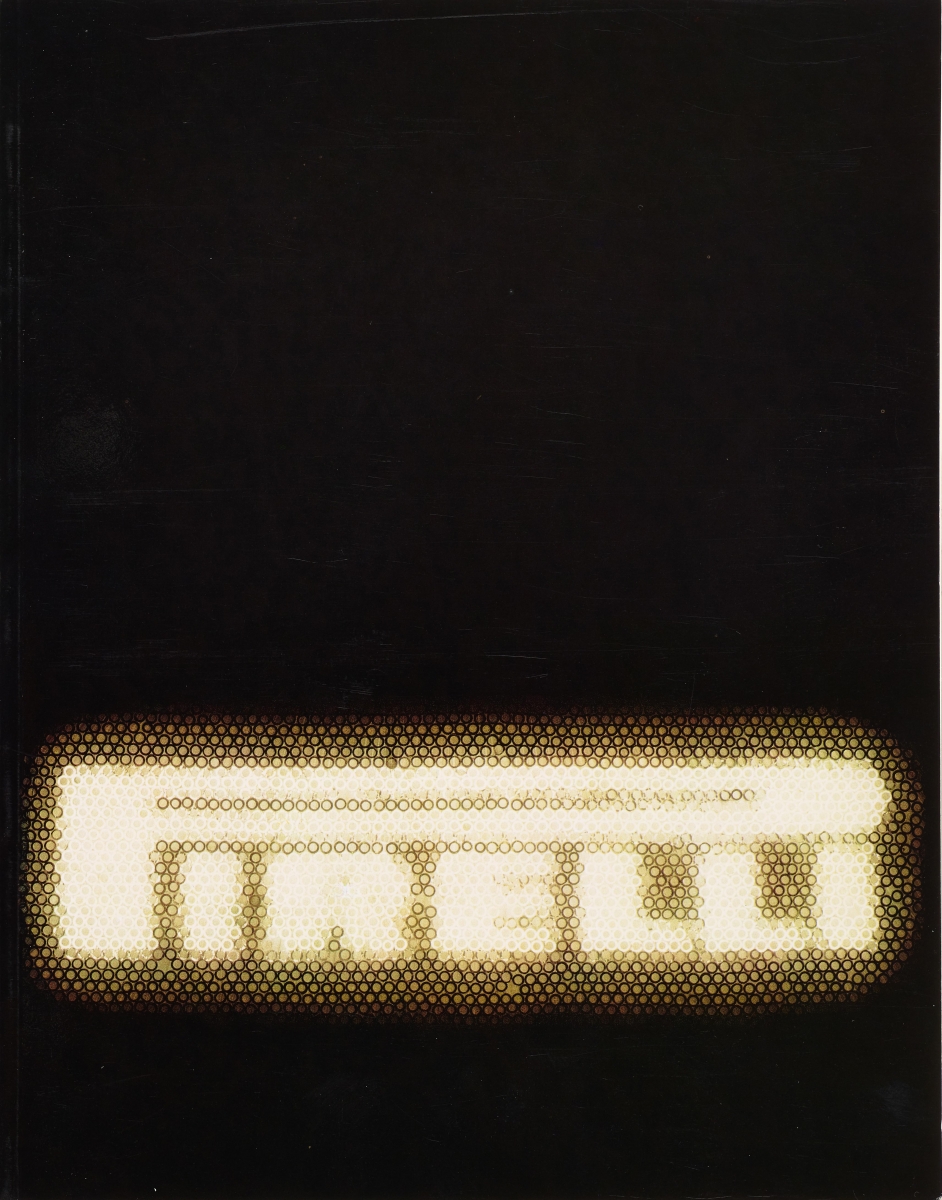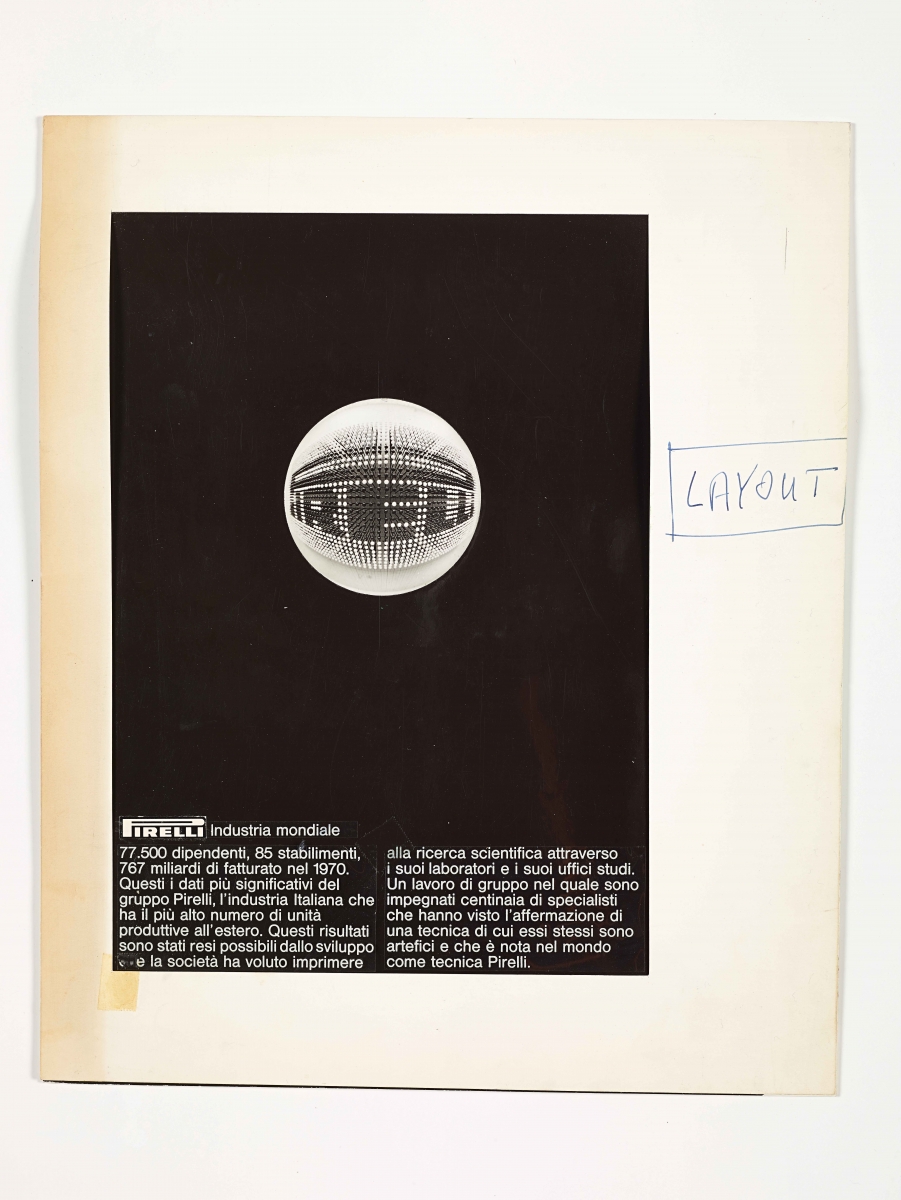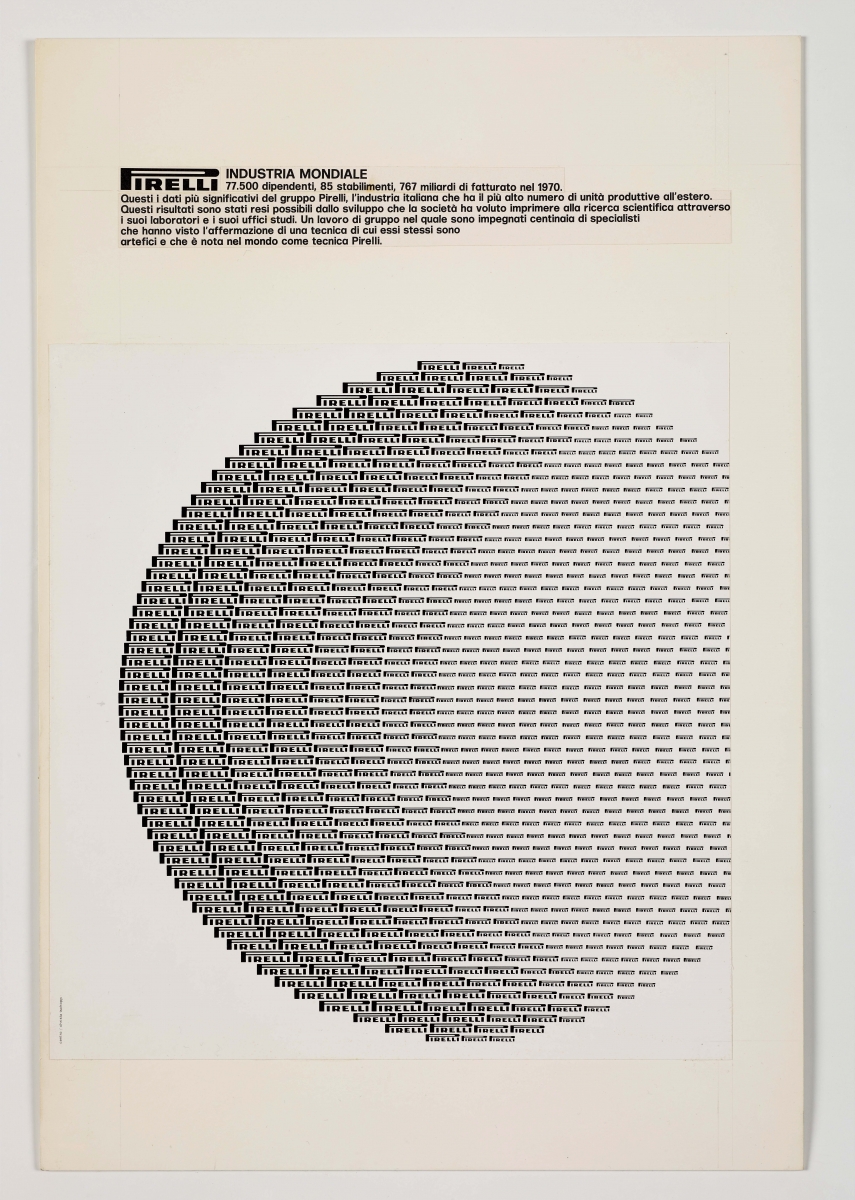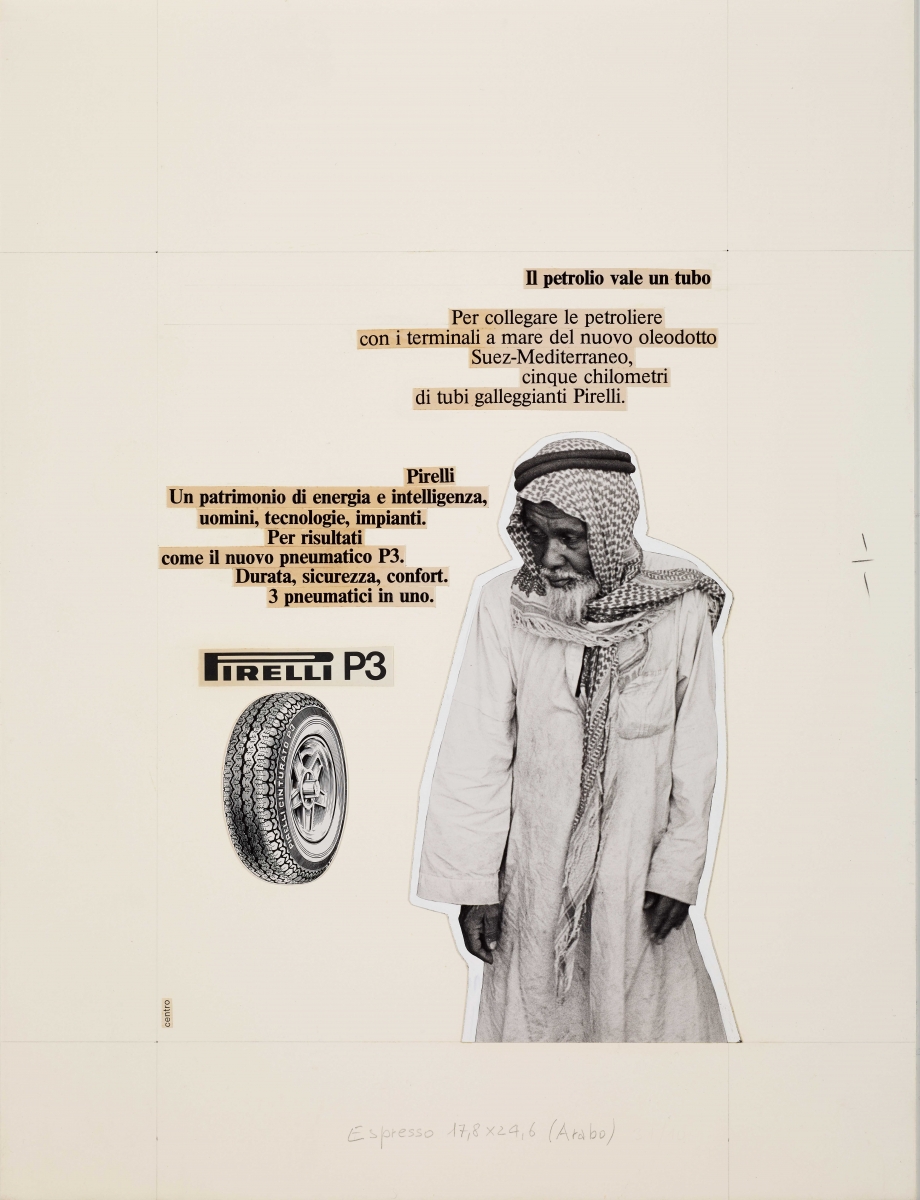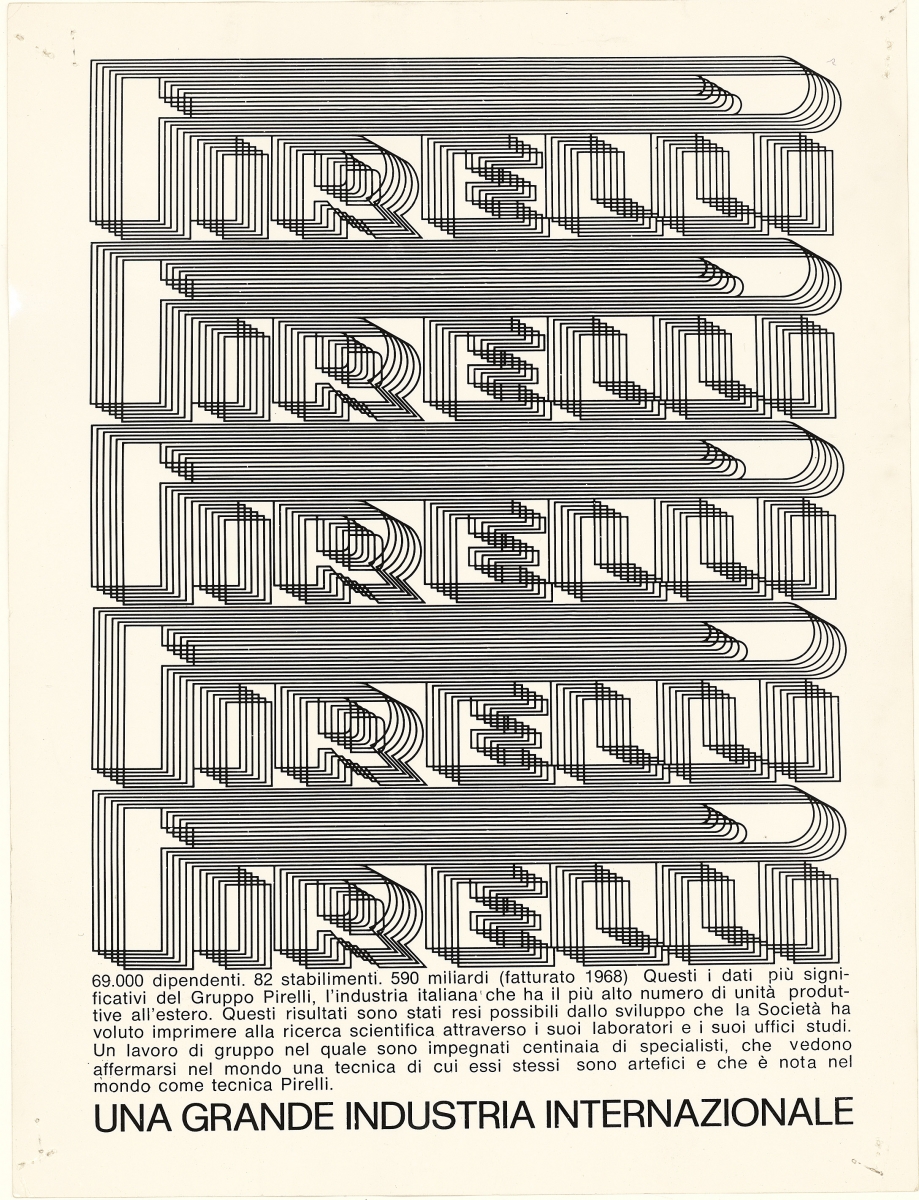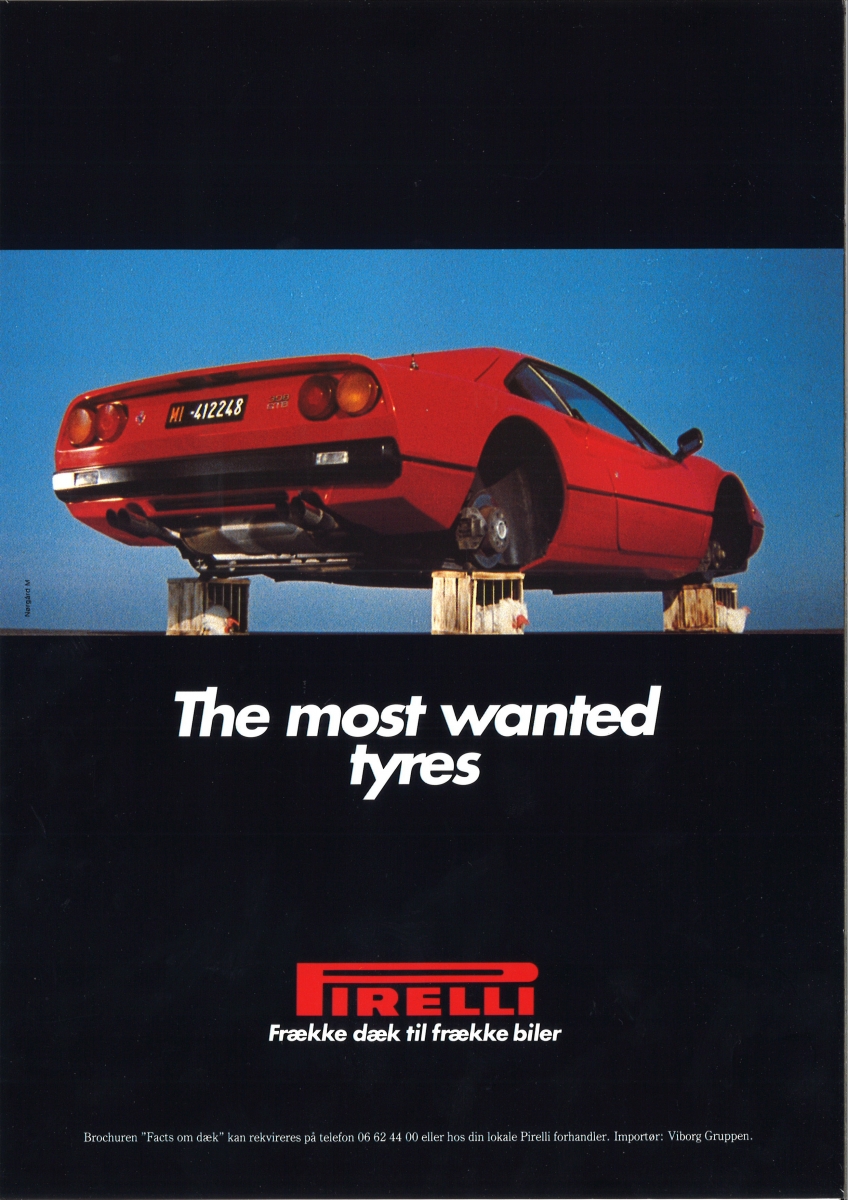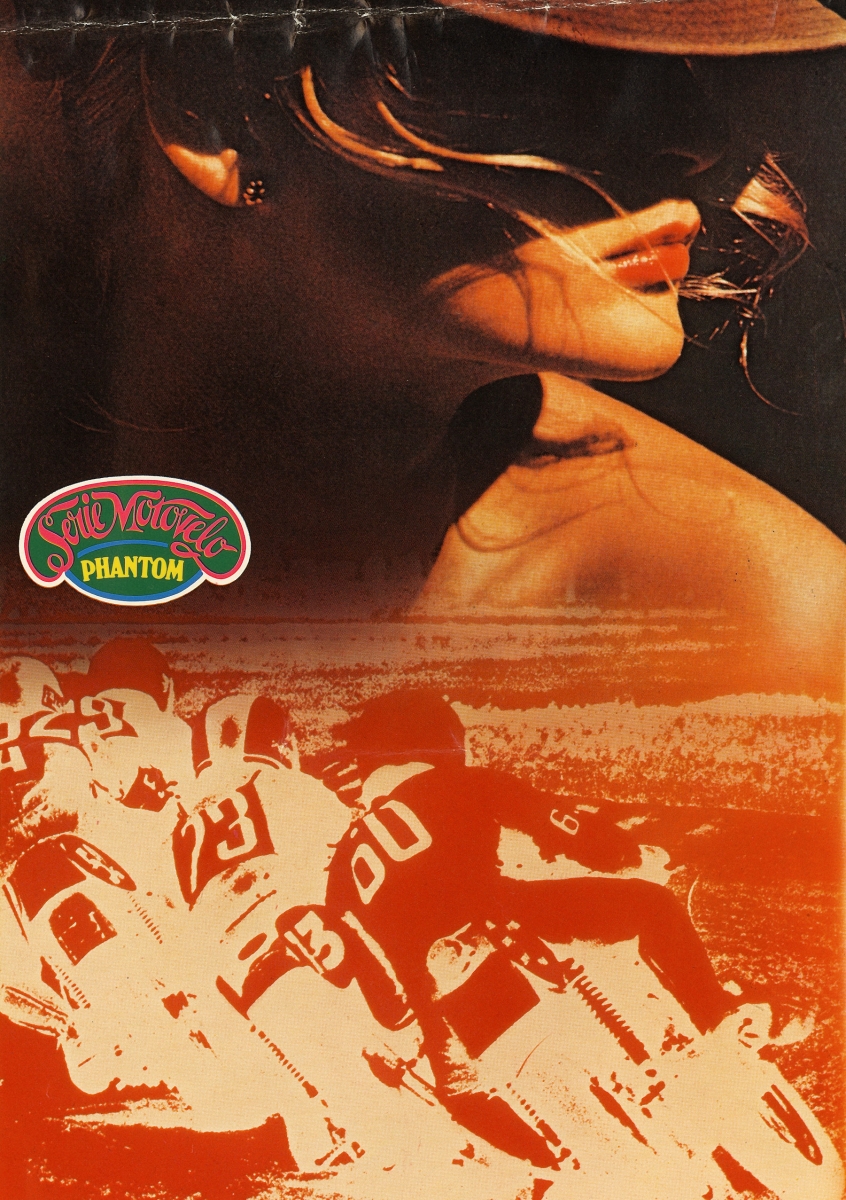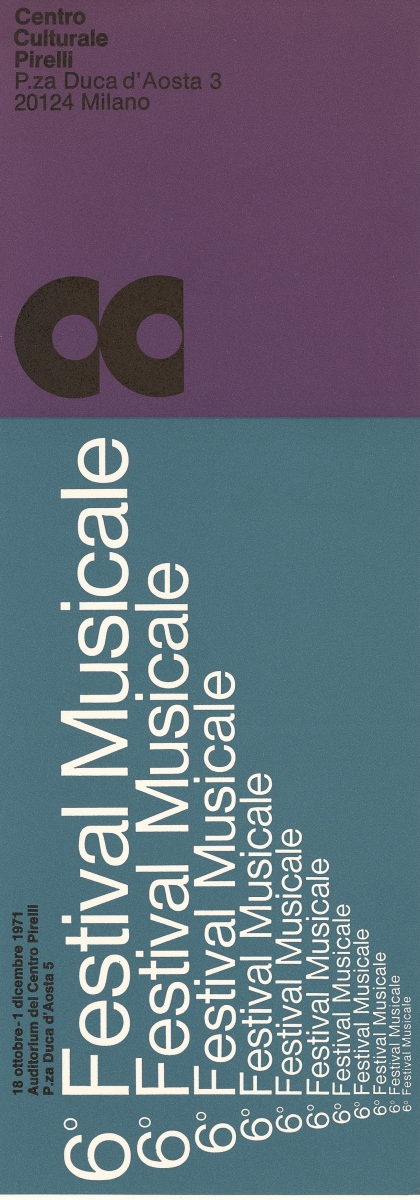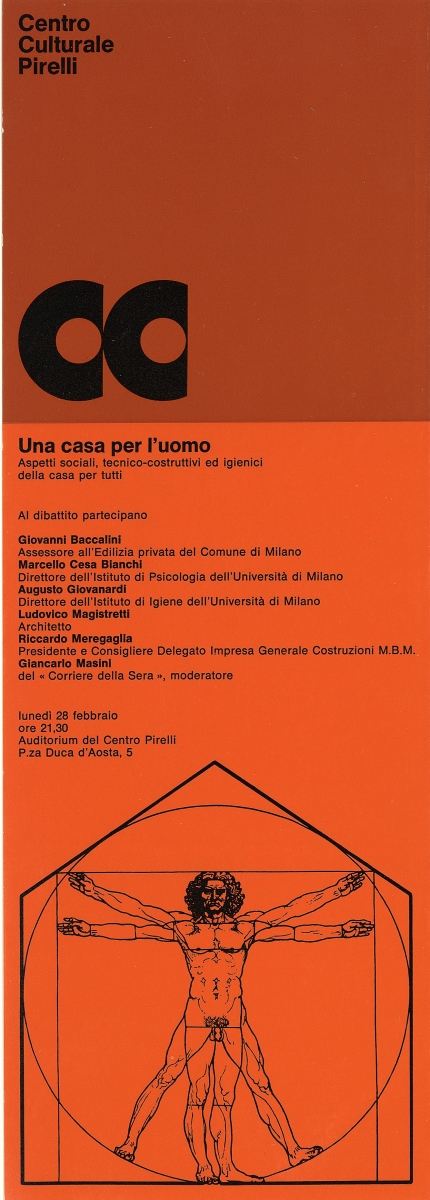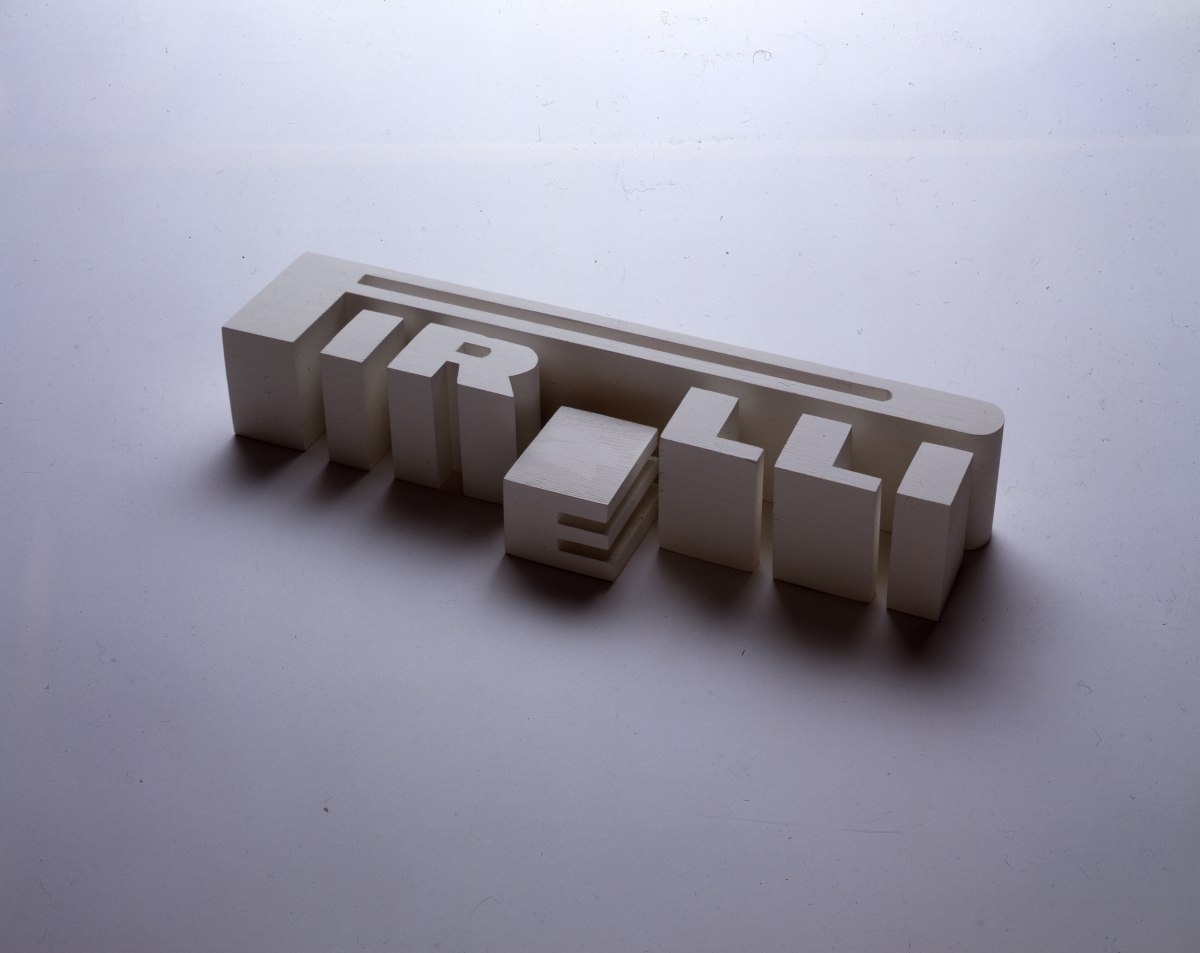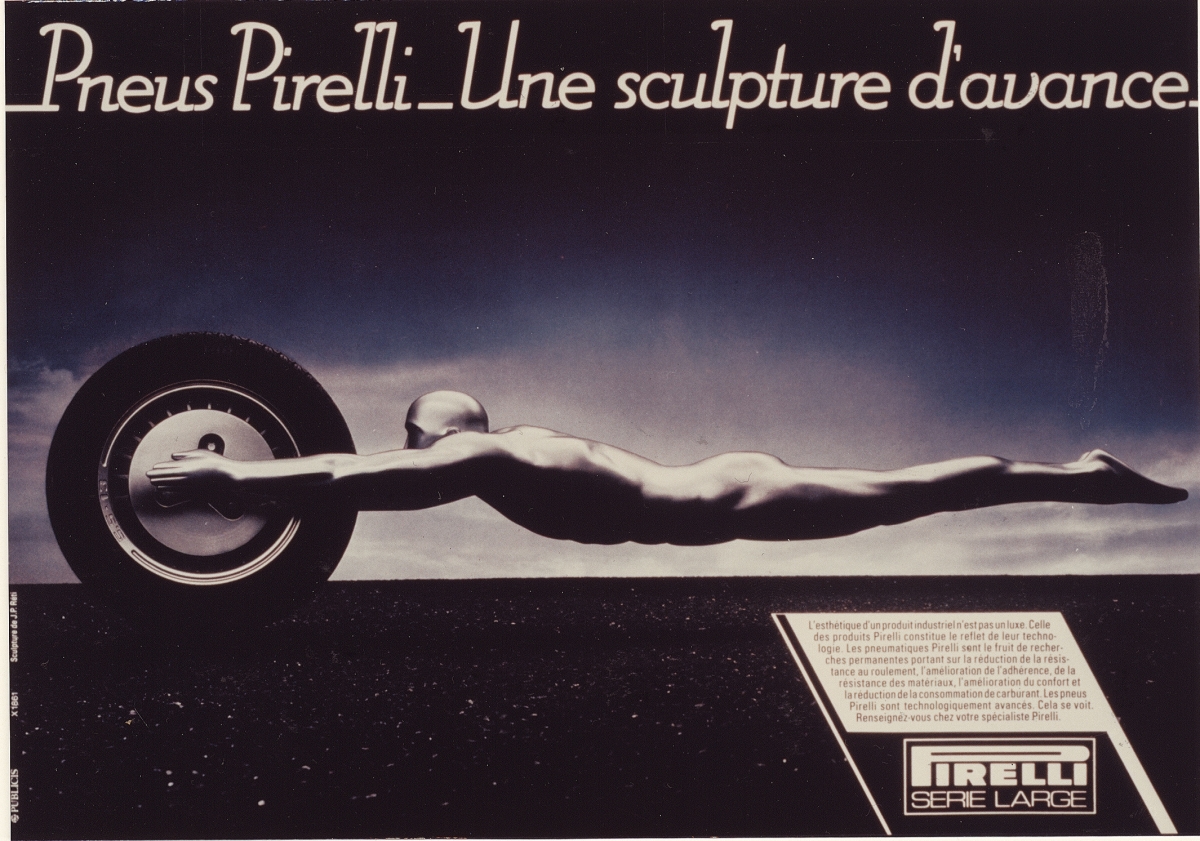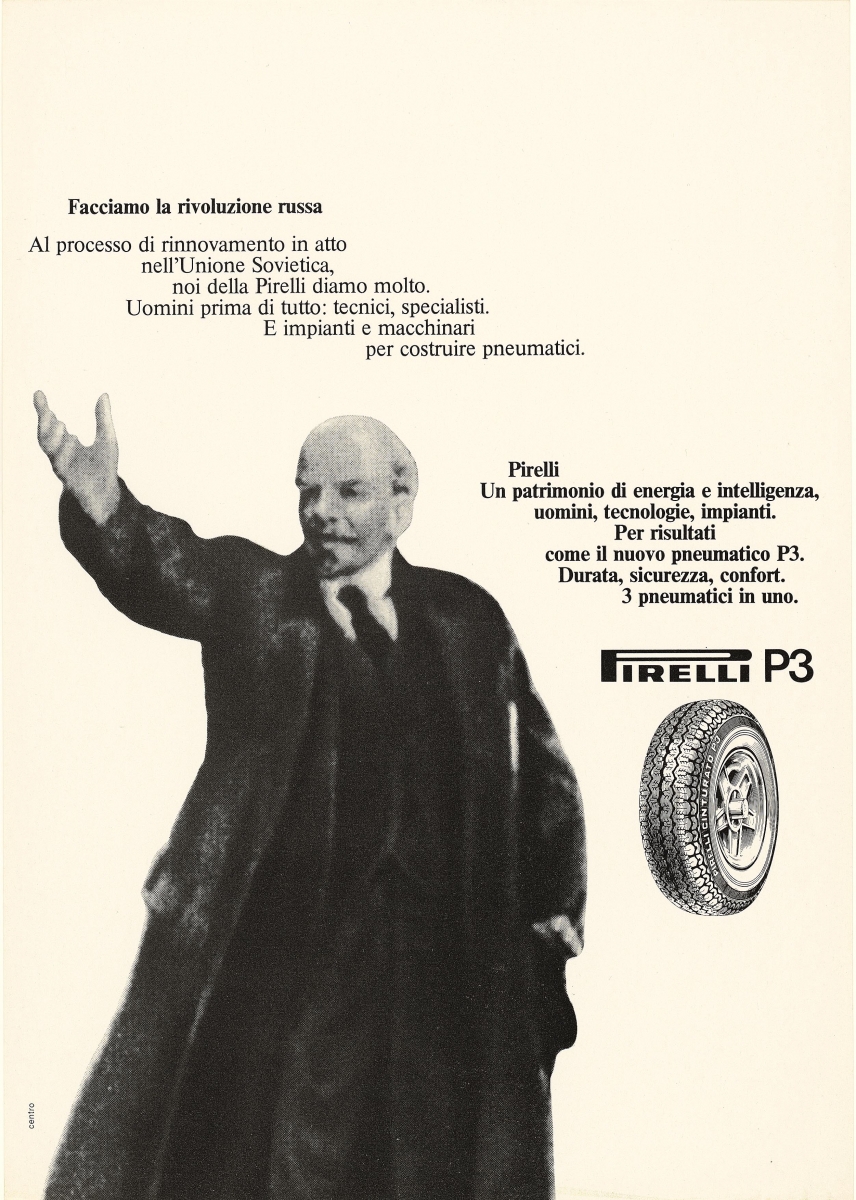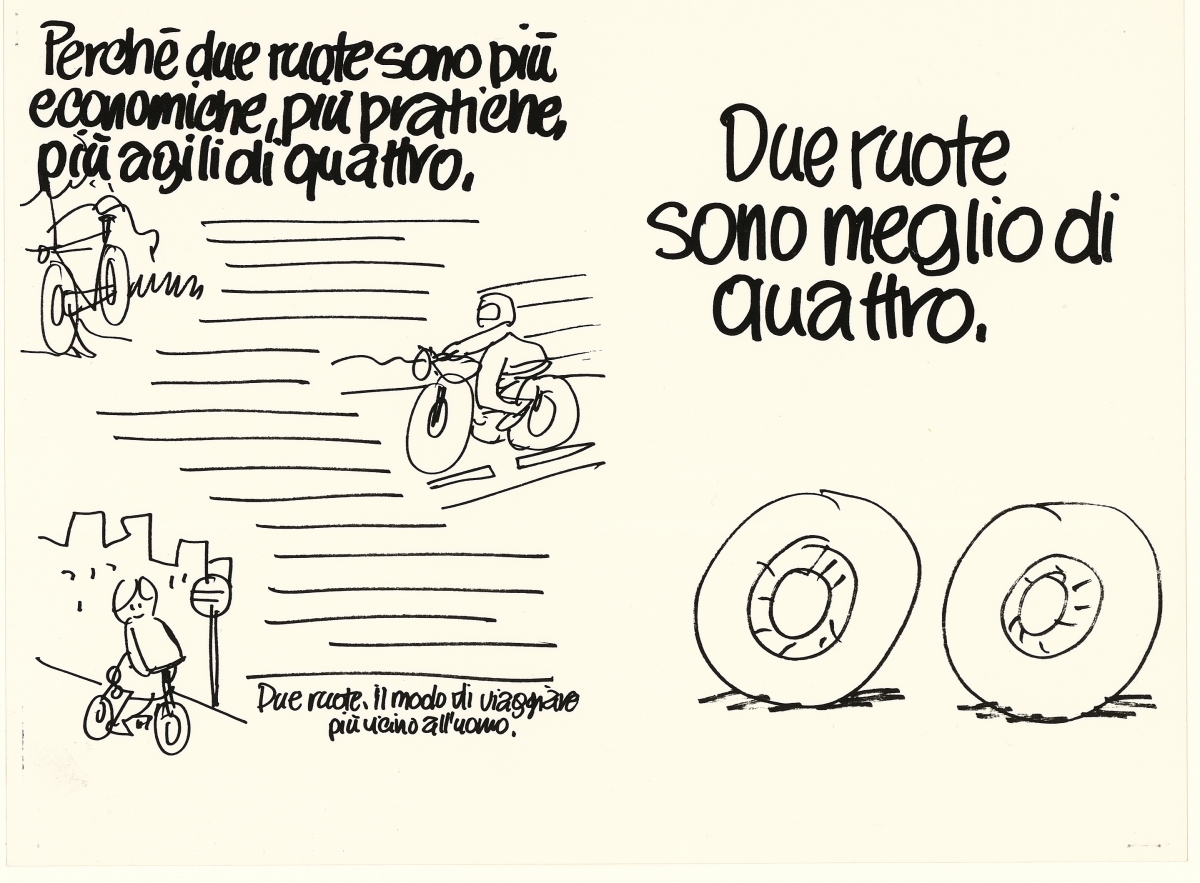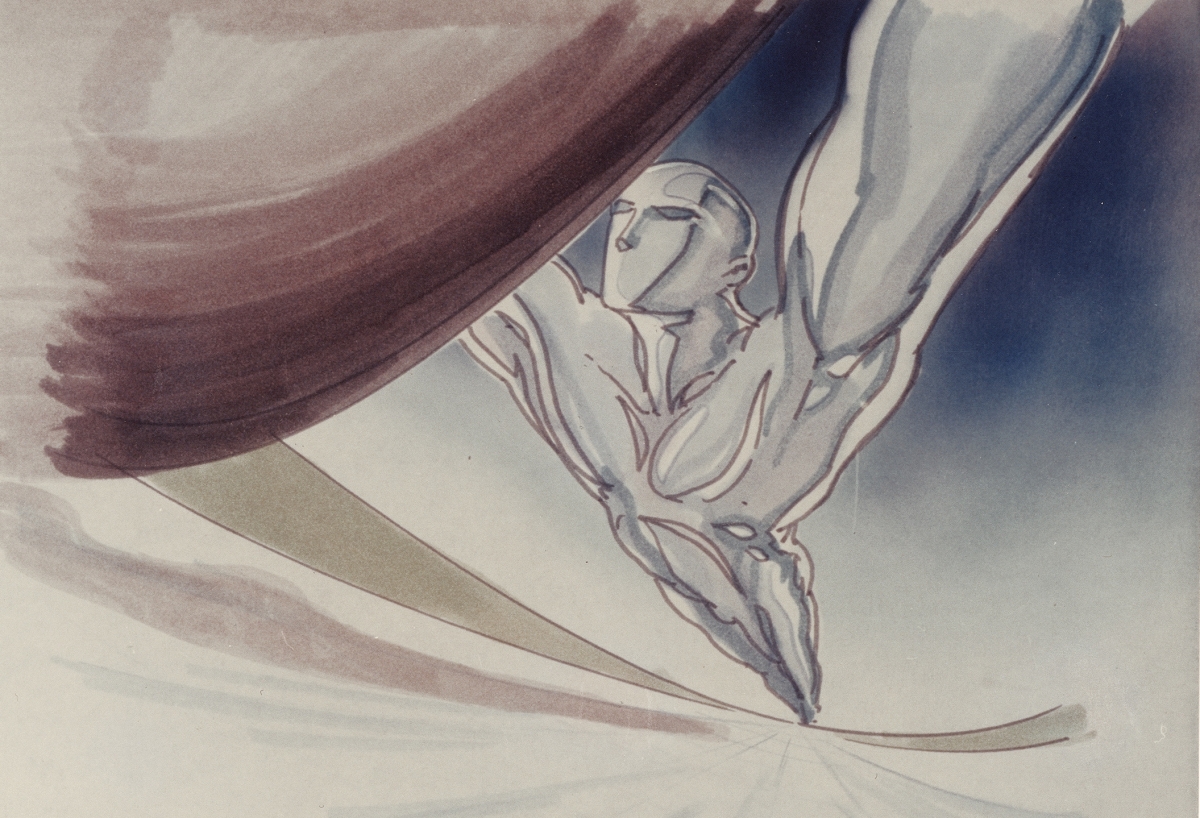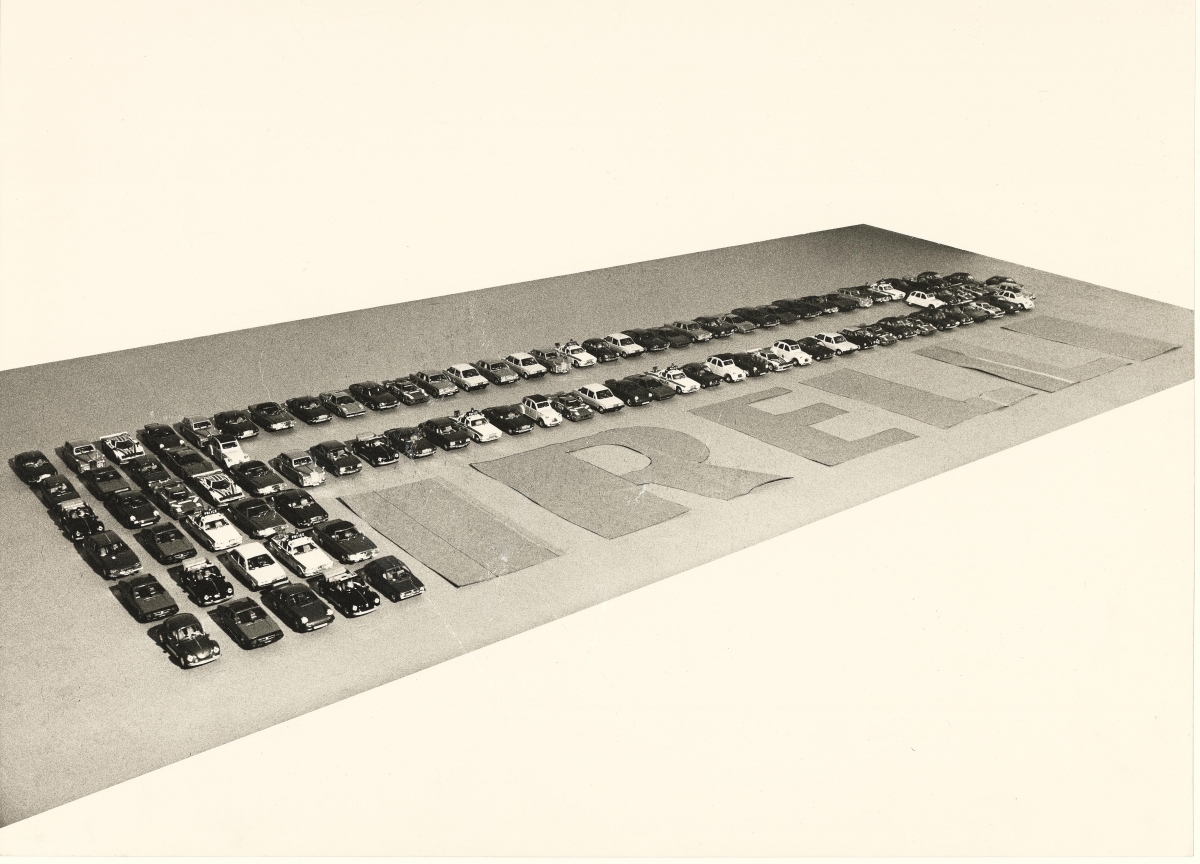Intangibilità d’impresa
In un libro il racconto degli aspetti immateriali del produrre e dei loro risvolti di mercato
Ogni impresa è anche qualcosa che non si vede ma che c’è. Qualcosa di intangibile, che nel tempo è stato definito come spirito imprenditoriale, capacità del “capo” di dare l’impronta giusta, organizzazione perfetta del tutto e anche – naturalmente -, cultura d’impresa che distingue appunto ogni azienda dalle altre. A ben vedere, l’intangibilità dell’impresa è esistita sempre, descritta magari un modi sintetici ma comunque presente in chi l’impresa l’ha conosciuta per davvero.
Adesso, tuttavia, questi aspetti assumono più importanza di prima, soprattutto nei rapporti con il mercato. Ed è quindi bello – oltre che utile -, leggere “Vendere l’immateriale. Intangible Marketing, Marketing Sensoriale, Marketing Narrativo” di Annamaria Milesi. Un libro che riesce, in poco meno di 200 pagine, a dare il senso degli aspetti immateriali del produrre collegandoli alle azioni necessarie di promozione e marketing aziendale.
Milesi – che ha maturato esperienze manageriali con ruoli di direttore marketing e direttore generale in aziende italiane e internazionali, nell’ambito del turismo, dei servizi alle imprese e delle fiere -, parte da una constatazione: le imprese sembrano concentrate soprattutto sul proprio capitale fisico e produttivo. Giusta verità che nasconde quanto invece le imprese dovrebbero fare: spostare lo sguardo verso quel patrimonio di cui spesso non sanno molto. Milesi lo definisce “Capitale Immateriale”. Che è come dire cultura del produrre che spesso inconsapevolmente è cresciuta e maturata in uffici e officine con gli anni e con il contributo dì più persone che hanno dato vita non solo a prodotti ma a qualcosa di diverso e di più.
Per Milesi, quindi, ripartire dal Capitale Immateriale (costituito da Fattori Immateriali) è il percorso da intraprendere. Il libro racconta questo cammino che passa da molti esempi d’impresa oltre che da un sistematizzazione di una materia ancora tutta da costruire e precisare. Milesi illustra così l’utilizzo di suoni, odori, profumi, colori, sapori, nella costruzione di innovative architetture olfattive e identità sensoriali di spazi, prodotti, aziende, territori, brand del retail contemporaneo; ma racconta anche di aziende come Starbucks, Technogym, Esselunga, Illy e di prodotti che hanno a che fare con l’alimentazione, lo svago, il commercio, i servizi. Si delinea una modalità di relazione nuova fra impresa e mercato. Si afferma in un certo modo la supremazia di emozioni e narrazioni nel nuovo paradigma della relazione con il consumatore.
Ricco di suggestioni (magari non tutte condivisibili ma comunque apprezzabili e da conoscere), il libro di Milesi racconta come il consumatore non sia comunque un personaggio da prendere in giro ma che, anzi, abbia alzato l’asticella delle sue aspettative; e parla di un mercato ispirato a ciò che viene indicato come “Umanizzazione della tecnologia”.
Milesi scrive con tono leggero e assolutamente leggibile. Dopo aver fissato i concetti di base, vengono quindi spiegate le tappe per arrivare a delineare ciò che è intangibile nell’impresa e quindi gli strumenti da usare. Chiudono il volume alcune storie di imprese che hanno fatto dell’intangibilità uno dei loro cavalli di battaglia.
Vendere l’immateriale. Intangible Marketing, Marketing Sensoriale, Marketing Narrativo
Annamaria Milesi
Guerini Next, 2017






In un libro il racconto degli aspetti immateriali del produrre e dei loro risvolti di mercato
Ogni impresa è anche qualcosa che non si vede ma che c’è. Qualcosa di intangibile, che nel tempo è stato definito come spirito imprenditoriale, capacità del “capo” di dare l’impronta giusta, organizzazione perfetta del tutto e anche – naturalmente -, cultura d’impresa che distingue appunto ogni azienda dalle altre. A ben vedere, l’intangibilità dell’impresa è esistita sempre, descritta magari un modi sintetici ma comunque presente in chi l’impresa l’ha conosciuta per davvero.
Adesso, tuttavia, questi aspetti assumono più importanza di prima, soprattutto nei rapporti con il mercato. Ed è quindi bello – oltre che utile -, leggere “Vendere l’immateriale. Intangible Marketing, Marketing Sensoriale, Marketing Narrativo” di Annamaria Milesi. Un libro che riesce, in poco meno di 200 pagine, a dare il senso degli aspetti immateriali del produrre collegandoli alle azioni necessarie di promozione e marketing aziendale.
Milesi – che ha maturato esperienze manageriali con ruoli di direttore marketing e direttore generale in aziende italiane e internazionali, nell’ambito del turismo, dei servizi alle imprese e delle fiere -, parte da una constatazione: le imprese sembrano concentrate soprattutto sul proprio capitale fisico e produttivo. Giusta verità che nasconde quanto invece le imprese dovrebbero fare: spostare lo sguardo verso quel patrimonio di cui spesso non sanno molto. Milesi lo definisce “Capitale Immateriale”. Che è come dire cultura del produrre che spesso inconsapevolmente è cresciuta e maturata in uffici e officine con gli anni e con il contributo dì più persone che hanno dato vita non solo a prodotti ma a qualcosa di diverso e di più.
Per Milesi, quindi, ripartire dal Capitale Immateriale (costituito da Fattori Immateriali) è il percorso da intraprendere. Il libro racconta questo cammino che passa da molti esempi d’impresa oltre che da un sistematizzazione di una materia ancora tutta da costruire e precisare. Milesi illustra così l’utilizzo di suoni, odori, profumi, colori, sapori, nella costruzione di innovative architetture olfattive e identità sensoriali di spazi, prodotti, aziende, territori, brand del retail contemporaneo; ma racconta anche di aziende come Starbucks, Technogym, Esselunga, Illy e di prodotti che hanno a che fare con l’alimentazione, lo svago, il commercio, i servizi. Si delinea una modalità di relazione nuova fra impresa e mercato. Si afferma in un certo modo la supremazia di emozioni e narrazioni nel nuovo paradigma della relazione con il consumatore.
Ricco di suggestioni (magari non tutte condivisibili ma comunque apprezzabili e da conoscere), il libro di Milesi racconta come il consumatore non sia comunque un personaggio da prendere in giro ma che, anzi, abbia alzato l’asticella delle sue aspettative; e parla di un mercato ispirato a ciò che viene indicato come “Umanizzazione della tecnologia”.
Milesi scrive con tono leggero e assolutamente leggibile. Dopo aver fissato i concetti di base, vengono quindi spiegate le tappe per arrivare a delineare ciò che è intangibile nell’impresa e quindi gli strumenti da usare. Chiudono il volume alcune storie di imprese che hanno fatto dell’intangibilità uno dei loro cavalli di battaglia.
Vendere l’immateriale. Intangible Marketing, Marketing Sensoriale, Marketing Narrativo
Annamaria Milesi
Guerini Next, 2017