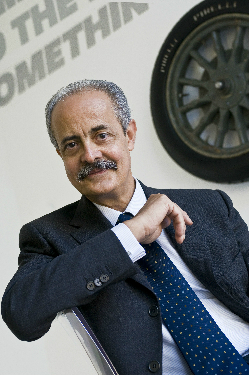Guide giuste per far crescere l’impresa
Gestire l’impresa è affascinante ma difficile. Non bastano conoscenze tecniche ed economiche, serve anche dell’altro cone la fantasia, l’inventiva, la scintilla imprenditoriale che fa separare i veri imprenditori dagli imitatori. Ma, in ogni caso, occorrono anche schemi d’azione validi, tracce di intervento affidabili, guide per percorsi complicati. Per questo per governare bene l’impresa ci vogliono manuali che riescano a dare uno schema conoscitivo utile al manager e all’imprenditore. “Libretti d’istruzioni” efficaci, che lascino spazio all’estro d’impresa, ma che forniscano affidabili indicazioni operative.
Pietro Genco (Professore Emerito all’Università di Genova), ha scritto un manuale che va nella direzione giusta. “Corporate governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa” – appena pubblicato a Torino -, contiene in poco più di 270 pagine una un sistemazione organica di una serie di discipline e ambiti di gestione aziendale spesso scollegati fra di loro. E’ quanto può essere utile per darsi uno schema della realtà d’impresa che si sta affrontando.
Il libro, scritto in linguaggio lineare, prende quindi in considerazione i diversi aspetti del “governo d’impresa”, illustrando anche i vari approcci che dipendono dalle differenti culture nelle quali le imprese si muovono (anglosassone, renano, giapponese, latino). L’autore è attento a non dimenticare il carattere culturale della produzione accanto a quello più strettamente tecnico ed economico.
L’attività di governo di una impresa viene, inoltre, vista non solo nei suoi aspetti interni all’azienda, ma anche facendo attenzione a quelli esterni considerando quindi l’azienda non come un sistema chiuso, ma come un’entità assolutamente aperta a tutte le sollecitazioni esterne.
Il volume si divide sostanzialmente in tre parti. Prima di tutto delinea un quadro di riferimento teorico del governo d’impresa, poi ne approfondisce i modelli che derivano da diverse culture economiche, infine prende in considerazione più da vicino gli assetti proprietari e di controllo delle imprese italiane e la struttura dei modelli di governance tra governo e controllo sempre per quanto riguarda l’Italia.
Insomma, la cultura d’impresa si nutre di ispirazioni e intuizioni, ma queste deve essere sostenute da tecnicalità adeguate.
Corporate governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa
Pietro Genco
G. Giappichelli Editore, 2014






Gestire l’impresa è affascinante ma difficile. Non bastano conoscenze tecniche ed economiche, serve anche dell’altro cone la fantasia, l’inventiva, la scintilla imprenditoriale che fa separare i veri imprenditori dagli imitatori. Ma, in ogni caso, occorrono anche schemi d’azione validi, tracce di intervento affidabili, guide per percorsi complicati. Per questo per governare bene l’impresa ci vogliono manuali che riescano a dare uno schema conoscitivo utile al manager e all’imprenditore. “Libretti d’istruzioni” efficaci, che lascino spazio all’estro d’impresa, ma che forniscano affidabili indicazioni operative.
Pietro Genco (Professore Emerito all’Università di Genova), ha scritto un manuale che va nella direzione giusta. “Corporate governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa” – appena pubblicato a Torino -, contiene in poco più di 270 pagine una un sistemazione organica di una serie di discipline e ambiti di gestione aziendale spesso scollegati fra di loro. E’ quanto può essere utile per darsi uno schema della realtà d’impresa che si sta affrontando.
Il libro, scritto in linguaggio lineare, prende quindi in considerazione i diversi aspetti del “governo d’impresa”, illustrando anche i vari approcci che dipendono dalle differenti culture nelle quali le imprese si muovono (anglosassone, renano, giapponese, latino). L’autore è attento a non dimenticare il carattere culturale della produzione accanto a quello più strettamente tecnico ed economico.
L’attività di governo di una impresa viene, inoltre, vista non solo nei suoi aspetti interni all’azienda, ma anche facendo attenzione a quelli esterni considerando quindi l’azienda non come un sistema chiuso, ma come un’entità assolutamente aperta a tutte le sollecitazioni esterne.
Il volume si divide sostanzialmente in tre parti. Prima di tutto delinea un quadro di riferimento teorico del governo d’impresa, poi ne approfondisce i modelli che derivano da diverse culture economiche, infine prende in considerazione più da vicino gli assetti proprietari e di controllo delle imprese italiane e la struttura dei modelli di governance tra governo e controllo sempre per quanto riguarda l’Italia.
Insomma, la cultura d’impresa si nutre di ispirazioni e intuizioni, ma queste deve essere sostenute da tecnicalità adeguate.
Corporate governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa
Pietro Genco
G. Giappichelli Editore, 2014