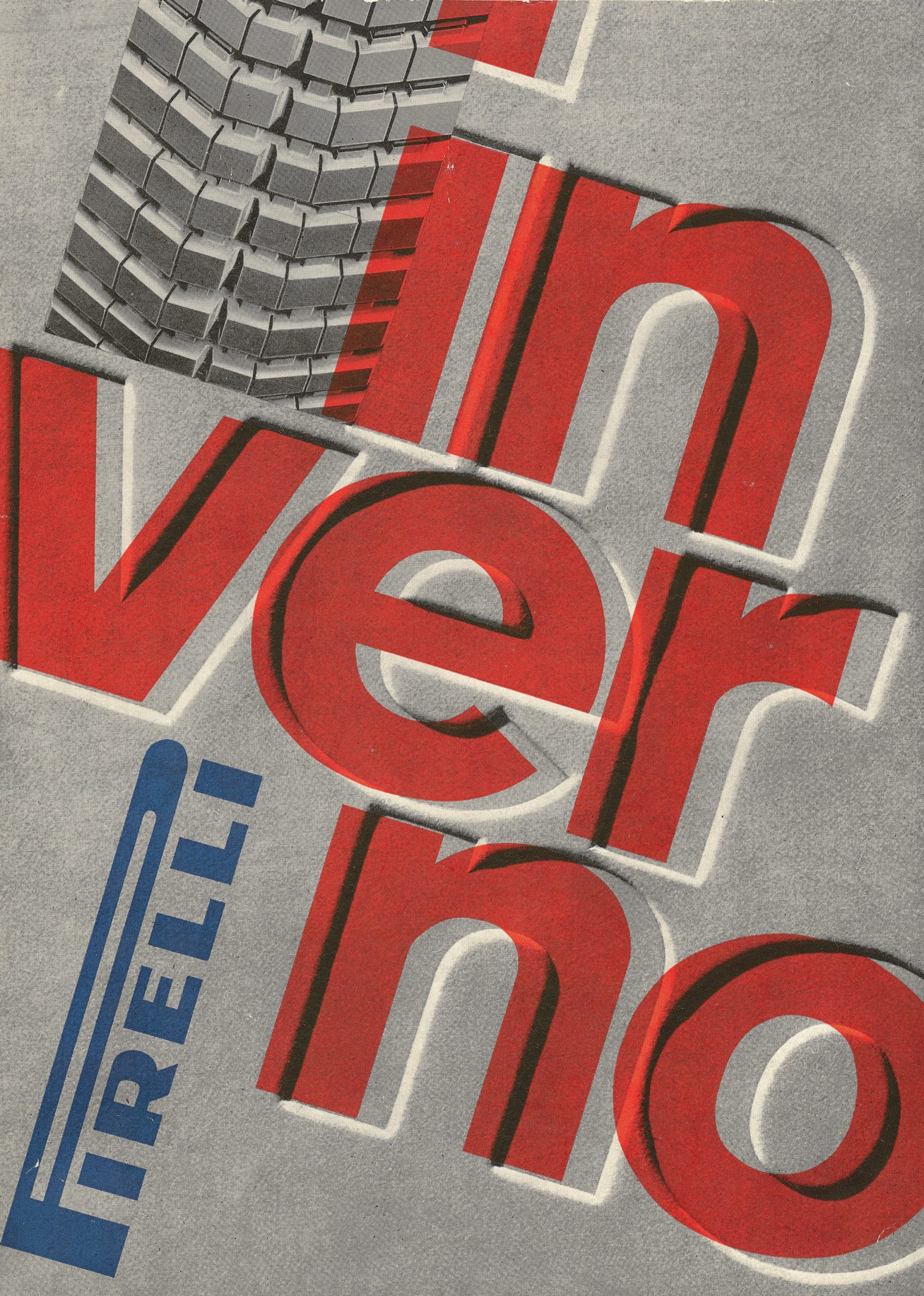L’Italia è un paese che invecchia: 48,7 anni è l’età media, di anno in anno in crescita e comunque già adesso la più alta tra i paesi della Ue (dati Eurostat). Ed è, contemporaneamente, il paese che fa meno figli, con un tasso di fertilità dell’1,18%: nel ‘24, documenta l’Istat, sono nati appena 370mila bambini, il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente e nei primi sei mesi del ‘25 le nascite sono state 13mila in meno dello stesso periodo del ‘24.
La crisi non finisce qui: i giovani preferiscono andare a cercare altrove migliori condizioni di lavoro e di vita (“Negli ultimi dieci anni oltre 337mila giovani italiani, di cui 120mila laureati, hanno lasciato il paese”, calcola Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria per Education e Open Innovation). E, quelli che restano, non sono affatto valorizzati né viene dato loro un orizzonte di fiducia: i cosiddetti Neet (le iniziali di Not in Education, Employment or Training) e cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano sono 1,3 milioni, il 15,2% nella loro fascia d’età.
Siamo, insomma, in una condizione di allarmante “inverno demografico”, tra vecchiaia che avanza (l’aspettativa di vita è salita alla media di 83,4 anni) e nascite che crollano. E, a peggiorare le cose, teniamo fuori dal lavoro e dall’ “economia della conoscenza” una parte troppo ampia delle nuove generazioni.
Il tema, trascurato per anni, è finalmente arrivato alla ribalta del discorso pubblico. Aumenta l’attenzione per gli studi demografici e le inchieste giornalistiche. Ma, conoscenza dei dati a parte, non si vedono ancora, a livello politico, scelte conseguenti per cominciare ad affrontare le relative questioni economiche, sociali e culturali.
Secondo l’Istat, nel 2050 i bambini saranno solo l’11,2% della popolazione. Avremo scuole vuote e professori disoccupati. E nell’arco dei prossimi anni mancheranno lavoratori e imprenditori (a meno di non costruire solide politiche per l’immigrazione). E diminuiranno le risorse per pagare il welfare, a cominciare dalle pensioni, per i tanti anziani.
La demografia è fenomeno di lunghe derive: anche se magicamente il fenomeno della bassa natalità venisse improvvisamente bloccato e cambiato di segno, ci vorrebbero almeno vent’anni prima che i neonati di oggi incidessero sul mercato del lavoro. E dunque, per affrontarne gli aspetti, sono necessarie scelte tempestive, ma anche intelligenti misure politiche per affrontare le situazioni intermedie.
Quali? La tendenza alla bassa natalità ha radici psicologiche, economiche e culturali: la crisi della famiglia tradizionale, la modifica della scala dei valori (la prevalenza dell’ “io” e dunque delle aspettative individuali, contrapposte alle responsabilità genitoriali e al “noi” della famiglia e della comunità), ma anche le strutture e le tendenze del mercato del lavoro che rendono ancora marginale la condizione di tante, troppe donne e le gravi carenze dell’offerta di abitazioni nei grandi centri urbani e dei servizi (a cominciare dagli asili nido e dalle scuole a tempo pieno). E, soprattutto, la caduta di fiducia nel futuro.
Ecco il punto: la crisi di fiducia. Il “patto generazionale” (i miei figli potranno vivere una condizione migliore della nostra, dunque vale la pena investire sulla loro formazione e la costruzione delle loro opportunità) s’è bloccato in Italia all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, con l’esplosione del debito pubblico (in sintesi, il costo del benessere dei contemporanei è stato scaricato sulle nuove generazioni) e anche in tutti gli altri paesi occidentali il mantenimento del welfare, a cominciare dalle pensioni, è stato pagato con l’indebitamento messo in conto a figli e nipoti).
Le tensioni geopolitiche internazionali, i guasti ambientali, le guerre commerciali, i disagi sociali crescenti e le difficoltà a reggere le stesse condizioni di qualità della vita dei genitori hanno aggravato tensioni e divari generazionali. Fare figli non è più una priorità.
Modificare questo ciclo è quanto mai difficile. Eppure, qualcosa di urgente e lungimirante bisogna fare, senza rassegnarsi al destino di declino e degrado, di caduta della spinta all’innovazione non solo economica ma anche sociale e culturale e dunque di crisi radicale di quanto di positivo proprio l’Europa e più in generale l’Occidente hanno costruito nel corso del Novecento, soprattutto nella seconda metà del secolo: la sintesi originale e positiva tra democrazia liberale, economia di mercato e welfare e cioè tra libertà, intraprendenza, valori del cambiamento e solidarietà, tra progresso e coesione sociale.
Ripensare dunque la politica. Il lavoro. La partecipazione. E imparare finalmente a legare lo sguardo lungo dell’ambizione alle trasformazioni con il riformismo pragmatico del buon governo.
Una conciliazione difficile. Ma possibile, se si dà ascolto a uno dei migliori intellettuali del Novecento, Ernst Cassirer: “La grande missione dell’utopia è di dare adito al possibile, in opposizione alla passiva acquiescenza all’attuale stato di cose. È il pensiero simbolico che trionfa della naturale inerzia dell’uomo e lo dota di una nuova facoltà, la facoltà di riformare continuamente il suo universo”.
Tenere il pensiero di Cassirer sullo sfondo, dunque, accanto a quello di Lewis Mumford, con la distinzione (i lettori di questo blog l’hanno già sentita ripetere) tra “utopia della fuga” e cioè la velleità di costruire castelli in aria e “utopia della ricostruzione” e cioè impegno a immaginare e costruire un pur ambizioso cambiamento. Ma anche, qui e adesso, pensare concretamente alla buona politica.
Come? Ricostruire fiducia, come obiettivo generale (ne abbiamo parlato nei blog del 6 maggio e del 7 ottobre). Dare un orizzonte di senso e di cambiamento alle nuove generazioni. Ma intanto fare scelte concrete. Utilizzare meglio le risorse che abbiamo e cioè le donne e i giovani, garantendo loro un migliore accesso al mercato del lavoro, con politiche di carriera e redditi adeguati alla loro formazione e alle loro capacità di trasformare le ambizioni in intraprendenza e operosità. Modificare il ciclo dell’abbandono dell’Italia da parte delle persone più intraprendenti e attive delle nuove generazioni, offrendo opportunità di crescita e, contemporaneamente, attirando risorse umane nuove dall’estero, soprattutto dai paesi del bacino del Mediterraneo. Insistere sulla formazione, superando il gap di conoscenza e comprensione (un terzo degli italiani è “analfabeta funzionale” e cioè non capisce un testo scritto di media complessità e non sa fare un calcolo poco più che elementare). E impegnare risorse adeguate, finanziarie e intellettuali, per recuperare alla convivenza civile e dunque alla partecipazione responsabile gran parte di quei Neet di cui abbiamo parlato.
Non è un catalogo delle buone intenzioni. Ma l’indicazione di parti convergenti di un unico disegno, lo sviluppo equilibrato dell’Italia europea. Un elenco di punti da tradurre in scelte di governo, in investimenti (usando bene i fondi della Ue), in impegni che coinvolgono le responsabilità non solo dei decisori politici ma anche degli attori economici e culturali.
Una sfida difficile, naturalmente. Ma essenziale. Per la crescita economica. Ma soprattutto per gli equilibri sociali.
Una “collaborazione di cittadinanza”, sostiene Confindustria, al termine di un convegno a Ortigia sull’Open Innovation e la formazione, appunto, per “fare risaltare talento, conoscenza, tecnologia e produttività” (Il Sole24Ore, 24 e 25 ottobre). E sono i Giovani Imprenditori di Confindustria, presieduti da Maria Anghileri, a insistere nei loro convegni sulla necessità di aprire l’impresa alle nuove generazioni, come spazio in cui realizzare progetti, idee, ambizioni, sogni. “L’impresa che cresce”, indicano come obiettivo. Impresa attore economico. E lievito sociale.
Da questo punto di vista, la scelta politica è chiara: la strategia che serve, anche dal punto di vista della politica industriale, è una politica della conoscenza, dell’innovazione e dunque della formazione.
Se abbiamo risorse scarse, i nostri giovani, è indispensabile qualificarle. Metterle in condizione di esprimere il meglio. E intanto lavorare per invertire il ciclo della chiusura impaurita nei microcosmi sociali e della caduta di natalità. Investire sulla ricostruzione di fiducia appunto. Su una buona idea di futuro.
(foto Getty Images)
L’Italia è un paese che invecchia: 48,7 anni è l’età media, di anno in anno in crescita e comunque già adesso la più alta tra i paesi della Ue (dati Eurostat). Ed è, contemporaneamente, il paese che fa meno figli, con un tasso di fertilità dell’1,18%: nel ‘24, documenta l’Istat, sono nati appena 370mila bambini, il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente e nei primi sei mesi del ‘25 le nascite sono state 13mila in meno dello stesso periodo del ‘24.
La crisi non finisce qui: i giovani preferiscono andare a cercare altrove migliori condizioni di lavoro e di vita (“Negli ultimi dieci anni oltre 337mila giovani italiani, di cui 120mila laureati, hanno lasciato il paese”, calcola Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria per Education e Open Innovation). E, quelli che restano, non sono affatto valorizzati né viene dato loro un orizzonte di fiducia: i cosiddetti Neet (le iniziali di Not in Education, Employment or Training) e cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano sono 1,3 milioni, il 15,2% nella loro fascia d’età.
Siamo, insomma, in una condizione di allarmante “inverno demografico”, tra vecchiaia che avanza (l’aspettativa di vita è salita alla media di 83,4 anni) e nascite che crollano. E, a peggiorare le cose, teniamo fuori dal lavoro e dall’ “economia della conoscenza” una parte troppo ampia delle nuove generazioni.
Il tema, trascurato per anni, è finalmente arrivato alla ribalta del discorso pubblico. Aumenta l’attenzione per gli studi demografici e le inchieste giornalistiche. Ma, conoscenza dei dati a parte, non si vedono ancora, a livello politico, scelte conseguenti per cominciare ad affrontare le relative questioni economiche, sociali e culturali.
Secondo l’Istat, nel 2050 i bambini saranno solo l’11,2% della popolazione. Avremo scuole vuote e professori disoccupati. E nell’arco dei prossimi anni mancheranno lavoratori e imprenditori (a meno di non costruire solide politiche per l’immigrazione). E diminuiranno le risorse per pagare il welfare, a cominciare dalle pensioni, per i tanti anziani.
La demografia è fenomeno di lunghe derive: anche se magicamente il fenomeno della bassa natalità venisse improvvisamente bloccato e cambiato di segno, ci vorrebbero almeno vent’anni prima che i neonati di oggi incidessero sul mercato del lavoro. E dunque, per affrontarne gli aspetti, sono necessarie scelte tempestive, ma anche intelligenti misure politiche per affrontare le situazioni intermedie.
Quali? La tendenza alla bassa natalità ha radici psicologiche, economiche e culturali: la crisi della famiglia tradizionale, la modifica della scala dei valori (la prevalenza dell’ “io” e dunque delle aspettative individuali, contrapposte alle responsabilità genitoriali e al “noi” della famiglia e della comunità), ma anche le strutture e le tendenze del mercato del lavoro che rendono ancora marginale la condizione di tante, troppe donne e le gravi carenze dell’offerta di abitazioni nei grandi centri urbani e dei servizi (a cominciare dagli asili nido e dalle scuole a tempo pieno). E, soprattutto, la caduta di fiducia nel futuro.
Ecco il punto: la crisi di fiducia. Il “patto generazionale” (i miei figli potranno vivere una condizione migliore della nostra, dunque vale la pena investire sulla loro formazione e la costruzione delle loro opportunità) s’è bloccato in Italia all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, con l’esplosione del debito pubblico (in sintesi, il costo del benessere dei contemporanei è stato scaricato sulle nuove generazioni) e anche in tutti gli altri paesi occidentali il mantenimento del welfare, a cominciare dalle pensioni, è stato pagato con l’indebitamento messo in conto a figli e nipoti).
Le tensioni geopolitiche internazionali, i guasti ambientali, le guerre commerciali, i disagi sociali crescenti e le difficoltà a reggere le stesse condizioni di qualità della vita dei genitori hanno aggravato tensioni e divari generazionali. Fare figli non è più una priorità.
Modificare questo ciclo è quanto mai difficile. Eppure, qualcosa di urgente e lungimirante bisogna fare, senza rassegnarsi al destino di declino e degrado, di caduta della spinta all’innovazione non solo economica ma anche sociale e culturale e dunque di crisi radicale di quanto di positivo proprio l’Europa e più in generale l’Occidente hanno costruito nel corso del Novecento, soprattutto nella seconda metà del secolo: la sintesi originale e positiva tra democrazia liberale, economia di mercato e welfare e cioè tra libertà, intraprendenza, valori del cambiamento e solidarietà, tra progresso e coesione sociale.
Ripensare dunque la politica. Il lavoro. La partecipazione. E imparare finalmente a legare lo sguardo lungo dell’ambizione alle trasformazioni con il riformismo pragmatico del buon governo.
Una conciliazione difficile. Ma possibile, se si dà ascolto a uno dei migliori intellettuali del Novecento, Ernst Cassirer: “La grande missione dell’utopia è di dare adito al possibile, in opposizione alla passiva acquiescenza all’attuale stato di cose. È il pensiero simbolico che trionfa della naturale inerzia dell’uomo e lo dota di una nuova facoltà, la facoltà di riformare continuamente il suo universo”.
Tenere il pensiero di Cassirer sullo sfondo, dunque, accanto a quello di Lewis Mumford, con la distinzione (i lettori di questo blog l’hanno già sentita ripetere) tra “utopia della fuga” e cioè la velleità di costruire castelli in aria e “utopia della ricostruzione” e cioè impegno a immaginare e costruire un pur ambizioso cambiamento. Ma anche, qui e adesso, pensare concretamente alla buona politica.
Come? Ricostruire fiducia, come obiettivo generale (ne abbiamo parlato nei blog del 6 maggio e del 7 ottobre). Dare un orizzonte di senso e di cambiamento alle nuove generazioni. Ma intanto fare scelte concrete. Utilizzare meglio le risorse che abbiamo e cioè le donne e i giovani, garantendo loro un migliore accesso al mercato del lavoro, con politiche di carriera e redditi adeguati alla loro formazione e alle loro capacità di trasformare le ambizioni in intraprendenza e operosità. Modificare il ciclo dell’abbandono dell’Italia da parte delle persone più intraprendenti e attive delle nuove generazioni, offrendo opportunità di crescita e, contemporaneamente, attirando risorse umane nuove dall’estero, soprattutto dai paesi del bacino del Mediterraneo. Insistere sulla formazione, superando il gap di conoscenza e comprensione (un terzo degli italiani è “analfabeta funzionale” e cioè non capisce un testo scritto di media complessità e non sa fare un calcolo poco più che elementare). E impegnare risorse adeguate, finanziarie e intellettuali, per recuperare alla convivenza civile e dunque alla partecipazione responsabile gran parte di quei Neet di cui abbiamo parlato.
Non è un catalogo delle buone intenzioni. Ma l’indicazione di parti convergenti di un unico disegno, lo sviluppo equilibrato dell’Italia europea. Un elenco di punti da tradurre in scelte di governo, in investimenti (usando bene i fondi della Ue), in impegni che coinvolgono le responsabilità non solo dei decisori politici ma anche degli attori economici e culturali.
Una sfida difficile, naturalmente. Ma essenziale. Per la crescita economica. Ma soprattutto per gli equilibri sociali.
Una “collaborazione di cittadinanza”, sostiene Confindustria, al termine di un convegno a Ortigia sull’Open Innovation e la formazione, appunto, per “fare risaltare talento, conoscenza, tecnologia e produttività” (Il Sole24Ore, 24 e 25 ottobre). E sono i Giovani Imprenditori di Confindustria, presieduti da Maria Anghileri, a insistere nei loro convegni sulla necessità di aprire l’impresa alle nuove generazioni, come spazio in cui realizzare progetti, idee, ambizioni, sogni. “L’impresa che cresce”, indicano come obiettivo. Impresa attore economico. E lievito sociale.
Da questo punto di vista, la scelta politica è chiara: la strategia che serve, anche dal punto di vista della politica industriale, è una politica della conoscenza, dell’innovazione e dunque della formazione.
Se abbiamo risorse scarse, i nostri giovani, è indispensabile qualificarle. Metterle in condizione di esprimere il meglio. E intanto lavorare per invertire il ciclo della chiusura impaurita nei microcosmi sociali e della caduta di natalità. Investire sulla ricostruzione di fiducia appunto. Su una buona idea di futuro.
(foto Getty Images)