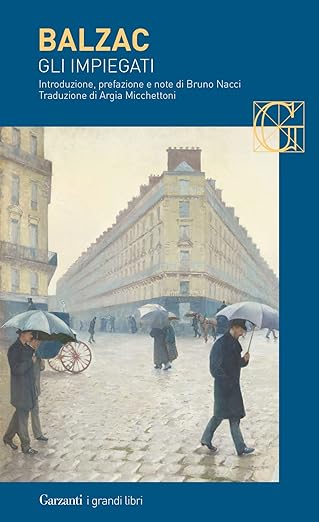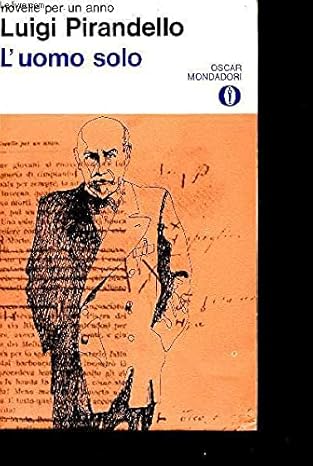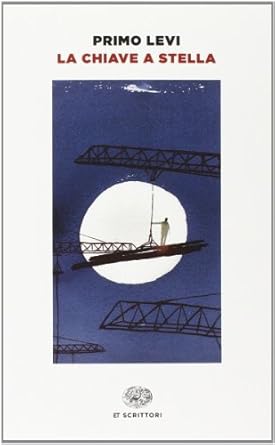Settembre, si riparte. Dando risposte ai dati che rivelano la crisi demografica e la mancanza di lavoratori di qualità
Arriva settembre, cambio di stagione. Sono finite le vacanze (quest’anno più brevi e risparmiose per migliaia di famiglie). La luce, non più diffusa come d’estate, comincia a subire le ombre nette e taglienti che annunciano l’autunno. E “lo stupore della notte spalancata sul mare” (secondo le parole di una delle più belle canzoni di Mina) cede il passo alla quotidianità del lavoro che riprende. Bisogna ritornare a fare i conti con una realtà malcerta e difficile.
Non si sono attenuate le tensioni delle guerre e dei conflitti geopolitici e commerciali. Tutt’altro. E si ripresentano davanti ai decisori politici e all’opinione pubblica tutte le questioni che per un momento avevamo tenuto un po’ meno da conto.
Un paio di dati, per ragionare (e per non dimenticare che senza numeri certi né statistiche autorevoli e attendibili non sono possibili né il buon governo né l’economia di mercato né, soprattutto, la democrazia). Il primo dato ha a che fare con la demografia: quest’anno nasceranno appena 340mila bambini, 30mila in meno rispetto al 2024, con un calo sempre più accentuato (nel ‘24, erano 10mila in meno che nel ‘23). Il secondo dato: le imprese cercano 2,3 milioni di laureati e diplomati tecnici ma ne trovano solo una parte e dunque crescono meno (Il Sole24Ore, 21 agosto).
Sono dati resi noti dai quotidiani proprio nei giorni d’estate (la buona informazione non va mai in vacanza; e senza di essa non ci sono né mercato né democrazia). Ma forse sono stati letti distrattamente, tra un tuffo al mare, un’affollata passeggiata in montagna e un gin tonic al tramonto, senza pensieri.
Perché partiamo da questi dati? Per indicare le questioni di fondo con cui fare i conti, per poter finalmente costruire progetti sostenibili di sviluppo e, guardando all’Europa, per impostare politiche di lungo periodo, evitando la marginalità e poi il declino (“L’illusione di un’Europa forte è già evaporata: è marginale e spettatrice”, ha ricordato Mario Draghi al Meeting di Rimini il 22 agosto) dell’area del mondo in cui sinora convivono valori e stili di vita essenziali, da difendere e rilanciare: l’economia libera, il welfare e, appunto, la democrazia rappresentativa. La libertà e la solidarietà. Il senso critico della storia e l’innovazione legata alla ricerca scientifica libera e autonoma. La memoria e il futuro. L’obiettivo: dare alle Ue una forte soggettività politica, a partire dai grandi temi della sicurezza, dell’energia, dell’innovazione, delle politiche industriali e della formazione (Sergio Fabbrini su Il Sole24Ore, 31 agosto).
I dati, dunque. Cominciando con quelli del cosiddetto “inverno demografico”, testimoniato sia dalla crescente diminuzione del numero dei nati di cui abbiamo appena detto e da un tasso di fecondità (1,18 figli per donna) tra i più bassi d’Europa (la media europea è di 1,38, quella mondiale è di 2,20). L’Ocse calcola che al 2060 l’Italia perderà 12 milioni di lavoratori attivi, una diminuzione del 34% rispetto a oggi, 4 volte maggiore della media dei 38 paesi Ocse. E se non salirà la produttività, il Pil pro capite scenderà in media dello 0,5% all’anno (Il Sole24Ore 25 e 29 luglio). In sintesi, stiamo diventando un paese sempre più vecchio, impoverito, segnato da disagi e solitudini (il 41% delle famiglie sarà formato nel 2050 da una persona sola, secondo l’Istat).
Ancora un dato inquietante: “Aule vuote: in dieci anni l’Italia perderà 1 milione di alunni”, secondo le statistiche Inail validate dal Mef , il ministero dell’Economia (Il Sole24Ore, 13 agosto).
Popolazione in discesa, lavoratori in diminuzione, “economia della conoscenza” privata dell’asset fondamentale e cioè le persone. Imprese in difficoltà. Crescita economica di medio periodo sempre più stentata.
Anche da questo punto di vista, il mercato del lavoro, ecco due serie di dati tra i tanti: “Allarme sulle lauree Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica): potrebbero mancare tra i 9mila e i 18mila lavoratori ogni anno”, stima il Rapporto Excelsior di Unioncamere, nel contesto di quel fabbisogno attuale di 2,3 milioni di laureati e diplomatici tecnici, in parte insoddisfatto, di cui abbiamo parlato all’inizio. Con conseguenze negative proprio su settori di punta della nostra competitività industriale. “Elettronica, la carenza di addetti frena sette imprese su dieci”, calcola l’Anie, l’associazione di settore di Confindustria (Il Sole24Ore, 26 agosto). E ancora: “Piccole imprese a corto di talenti: tre su quattro faticano a trovare competenze e profili. Per i posti da operaio specializzato vanno deserti 4 colloqui su 10”, Corriere della Sera, 31 agosto su dati Unioncamere/ ministero del Lavoro rielaborati dalla Cgia di Mestre).
Giavazzi
“Economia reale anemica”, sentenzia Carlo Cottarelli (Corriere della Sera, 12 agosto), anche se i dati sull’occupazione sono generalmente positivi (24milioni 326mila occupati a giugno, in crescita sui mesi precedenti) e – aggiunge Cottarelli – “i conti pubblici in ordine danno credibilità all’Italia”.
Ci sono altri dati da ricordare, accanto a quelli dell’inverno demografico e del mismatch tra offerta e domanda di lavoro. Tra il 2011 e il 2024 oltre 619mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia, con un saldo netto negativo di 433mila unità. E il fenomeno è in crescita: solo nel ‘24, il saldo stimato ha superato le 55mila unità, quasi cinque volte il livello del 2011. “L’Italia continua a perdere giovani e non è solo una questione numerica: è una perdita di capitale umano, di energie, di prosperità futura”, sostiene Luca Paolazzi (Huffington Post, 16 luglio).
Sorprendente – insiste Paolazzi – la geografia dell’esodo: le regioni più colpite sono soprattutto le più sviluppate: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, in cui oltre il 50% dei giovani emigrati ha almeno una laurea: “Un’emigrazione selettiva, che coinvolge i più formati, spesso attratti da contesti esteri dove il titolo di studio ha un valore più riconosciuto e le prospettive di carriera sono più chiare”.
Una perdita pesantissima di capitale umano e di capitale sociale che nel medio periodo può drasticamente abbattere le prospettive di crescita economica e di sviluppo sostenibile dell’Italia, condannandola alla marginalità, non solo economica ma anche politica.
“C’è un legame inscindibile tra nascite e crescita”, documenta Alessandro Rosina, autorevole demografo (Il Sole24Ore, 25 luglio), ricordando che “il Pil dipende da tre elementi: il numero di persone in età attiva, il tasso di occupazione, la produttività. E tutti questi fattori sono legati in modo interdipendente con i meccanismi delle dinamiche demografiche”.
Ecco il punto politico: fare scelte che insistano sulla qualità della vita e del lavoro, sulla formazione, sulla sostenibilità dei processi economici e sociali, sull’attrattività dell’Italia nei confronti di giovani che vengano dal resto del mondo e qui da noi vogliano costruire un migliore futuro. L’obiettivo, spiega Rosina, è “rendere l’Italia un paese in cui si può lavorare bene, crescere bene fin dall’infanzia, vivere bene in tutte le fasi della vita, scegliere di rimanere, integrare positivamente esperienze e provenienze diverse. Puntiamo la barra in questa direzione e ci troveremo anche con più benessere economico e più figli desiderati”.
Sarebbe importante, nella nostra ripresa d’attività, in politica e nelle imprese, muoversi in questa direzione. E trovarne tracce concrete e lungimiranti fin dalla prossima Legge Finanziaria che il governo si prepara a varare. Con senso di responsabilità per un’Italia migliore, più competitiva, attrattiva e solidale.
(Foto Getty Images)






Arriva settembre, cambio di stagione. Sono finite le vacanze (quest’anno più brevi e risparmiose per migliaia di famiglie). La luce, non più diffusa come d’estate, comincia a subire le ombre nette e taglienti che annunciano l’autunno. E “lo stupore della notte spalancata sul mare” (secondo le parole di una delle più belle canzoni di Mina) cede il passo alla quotidianità del lavoro che riprende. Bisogna ritornare a fare i conti con una realtà malcerta e difficile.
Non si sono attenuate le tensioni delle guerre e dei conflitti geopolitici e commerciali. Tutt’altro. E si ripresentano davanti ai decisori politici e all’opinione pubblica tutte le questioni che per un momento avevamo tenuto un po’ meno da conto.
Un paio di dati, per ragionare (e per non dimenticare che senza numeri certi né statistiche autorevoli e attendibili non sono possibili né il buon governo né l’economia di mercato né, soprattutto, la democrazia). Il primo dato ha a che fare con la demografia: quest’anno nasceranno appena 340mila bambini, 30mila in meno rispetto al 2024, con un calo sempre più accentuato (nel ‘24, erano 10mila in meno che nel ‘23). Il secondo dato: le imprese cercano 2,3 milioni di laureati e diplomati tecnici ma ne trovano solo una parte e dunque crescono meno (Il Sole24Ore, 21 agosto).
Sono dati resi noti dai quotidiani proprio nei giorni d’estate (la buona informazione non va mai in vacanza; e senza di essa non ci sono né mercato né democrazia). Ma forse sono stati letti distrattamente, tra un tuffo al mare, un’affollata passeggiata in montagna e un gin tonic al tramonto, senza pensieri.
Perché partiamo da questi dati? Per indicare le questioni di fondo con cui fare i conti, per poter finalmente costruire progetti sostenibili di sviluppo e, guardando all’Europa, per impostare politiche di lungo periodo, evitando la marginalità e poi il declino (“L’illusione di un’Europa forte è già evaporata: è marginale e spettatrice”, ha ricordato Mario Draghi al Meeting di Rimini il 22 agosto) dell’area del mondo in cui sinora convivono valori e stili di vita essenziali, da difendere e rilanciare: l’economia libera, il welfare e, appunto, la democrazia rappresentativa. La libertà e la solidarietà. Il senso critico della storia e l’innovazione legata alla ricerca scientifica libera e autonoma. La memoria e il futuro. L’obiettivo: dare alle Ue una forte soggettività politica, a partire dai grandi temi della sicurezza, dell’energia, dell’innovazione, delle politiche industriali e della formazione (Sergio Fabbrini su Il Sole24Ore, 31 agosto).
I dati, dunque. Cominciando con quelli del cosiddetto “inverno demografico”, testimoniato sia dalla crescente diminuzione del numero dei nati di cui abbiamo appena detto e da un tasso di fecondità (1,18 figli per donna) tra i più bassi d’Europa (la media europea è di 1,38, quella mondiale è di 2,20). L’Ocse calcola che al 2060 l’Italia perderà 12 milioni di lavoratori attivi, una diminuzione del 34% rispetto a oggi, 4 volte maggiore della media dei 38 paesi Ocse. E se non salirà la produttività, il Pil pro capite scenderà in media dello 0,5% all’anno (Il Sole24Ore 25 e 29 luglio). In sintesi, stiamo diventando un paese sempre più vecchio, impoverito, segnato da disagi e solitudini (il 41% delle famiglie sarà formato nel 2050 da una persona sola, secondo l’Istat).
Ancora un dato inquietante: “Aule vuote: in dieci anni l’Italia perderà 1 milione di alunni”, secondo le statistiche Inail validate dal Mef , il ministero dell’Economia (Il Sole24Ore, 13 agosto).
Popolazione in discesa, lavoratori in diminuzione, “economia della conoscenza” privata dell’asset fondamentale e cioè le persone. Imprese in difficoltà. Crescita economica di medio periodo sempre più stentata.
Anche da questo punto di vista, il mercato del lavoro, ecco due serie di dati tra i tanti: “Allarme sulle lauree Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica): potrebbero mancare tra i 9mila e i 18mila lavoratori ogni anno”, stima il Rapporto Excelsior di Unioncamere, nel contesto di quel fabbisogno attuale di 2,3 milioni di laureati e diplomatici tecnici, in parte insoddisfatto, di cui abbiamo parlato all’inizio. Con conseguenze negative proprio su settori di punta della nostra competitività industriale. “Elettronica, la carenza di addetti frena sette imprese su dieci”, calcola l’Anie, l’associazione di settore di Confindustria (Il Sole24Ore, 26 agosto). E ancora: “Piccole imprese a corto di talenti: tre su quattro faticano a trovare competenze e profili. Per i posti da operaio specializzato vanno deserti 4 colloqui su 10”, Corriere della Sera, 31 agosto su dati Unioncamere/ ministero del Lavoro rielaborati dalla Cgia di Mestre).
Giavazzi
“Economia reale anemica”, sentenzia Carlo Cottarelli (Corriere della Sera, 12 agosto), anche se i dati sull’occupazione sono generalmente positivi (24milioni 326mila occupati a giugno, in crescita sui mesi precedenti) e – aggiunge Cottarelli – “i conti pubblici in ordine danno credibilità all’Italia”.
Ci sono altri dati da ricordare, accanto a quelli dell’inverno demografico e del mismatch tra offerta e domanda di lavoro. Tra il 2011 e il 2024 oltre 619mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’Italia, con un saldo netto negativo di 433mila unità. E il fenomeno è in crescita: solo nel ‘24, il saldo stimato ha superato le 55mila unità, quasi cinque volte il livello del 2011. “L’Italia continua a perdere giovani e non è solo una questione numerica: è una perdita di capitale umano, di energie, di prosperità futura”, sostiene Luca Paolazzi (Huffington Post, 16 luglio).
Sorprendente – insiste Paolazzi – la geografia dell’esodo: le regioni più colpite sono soprattutto le più sviluppate: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, in cui oltre il 50% dei giovani emigrati ha almeno una laurea: “Un’emigrazione selettiva, che coinvolge i più formati, spesso attratti da contesti esteri dove il titolo di studio ha un valore più riconosciuto e le prospettive di carriera sono più chiare”.
Una perdita pesantissima di capitale umano e di capitale sociale che nel medio periodo può drasticamente abbattere le prospettive di crescita economica e di sviluppo sostenibile dell’Italia, condannandola alla marginalità, non solo economica ma anche politica.
“C’è un legame inscindibile tra nascite e crescita”, documenta Alessandro Rosina, autorevole demografo (Il Sole24Ore, 25 luglio), ricordando che “il Pil dipende da tre elementi: il numero di persone in età attiva, il tasso di occupazione, la produttività. E tutti questi fattori sono legati in modo interdipendente con i meccanismi delle dinamiche demografiche”.
Ecco il punto politico: fare scelte che insistano sulla qualità della vita e del lavoro, sulla formazione, sulla sostenibilità dei processi economici e sociali, sull’attrattività dell’Italia nei confronti di giovani che vengano dal resto del mondo e qui da noi vogliano costruire un migliore futuro. L’obiettivo, spiega Rosina, è “rendere l’Italia un paese in cui si può lavorare bene, crescere bene fin dall’infanzia, vivere bene in tutte le fasi della vita, scegliere di rimanere, integrare positivamente esperienze e provenienze diverse. Puntiamo la barra in questa direzione e ci troveremo anche con più benessere economico e più figli desiderati”.
Sarebbe importante, nella nostra ripresa d’attività, in politica e nelle imprese, muoversi in questa direzione. E trovarne tracce concrete e lungimiranti fin dalla prossima Legge Finanziaria che il governo si prepara a varare. Con senso di responsabilità per un’Italia migliore, più competitiva, attrattiva e solidale.
(Foto Getty Images)