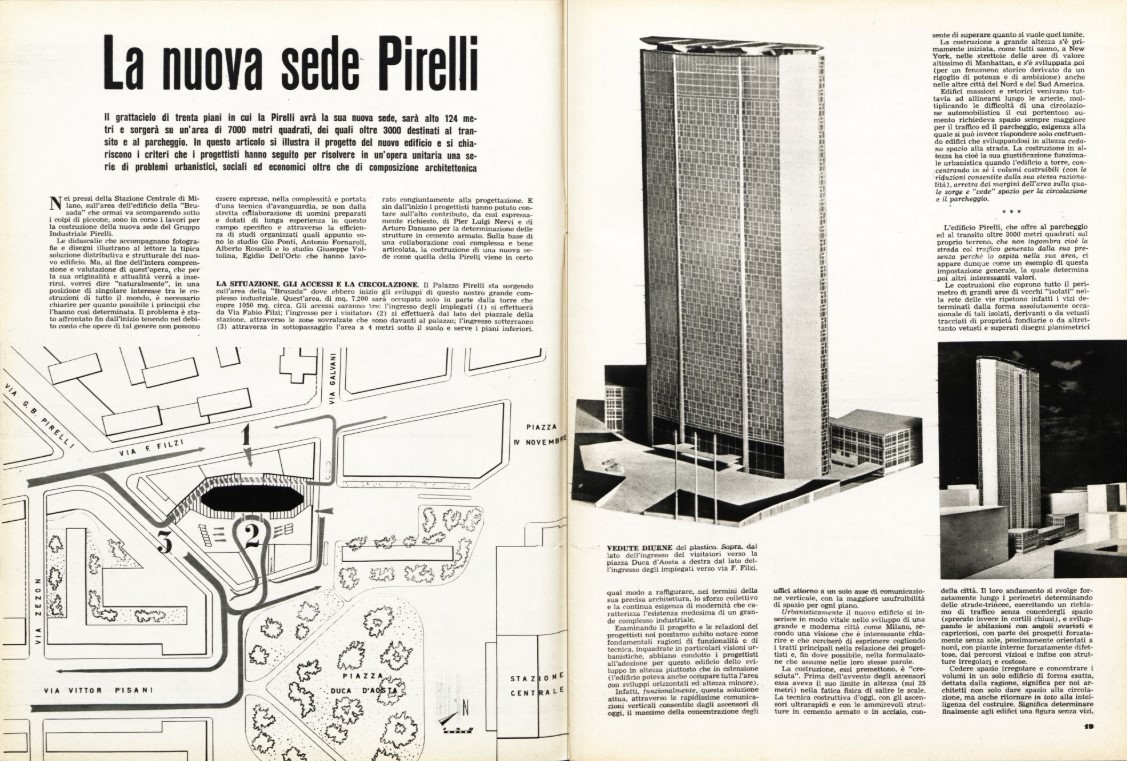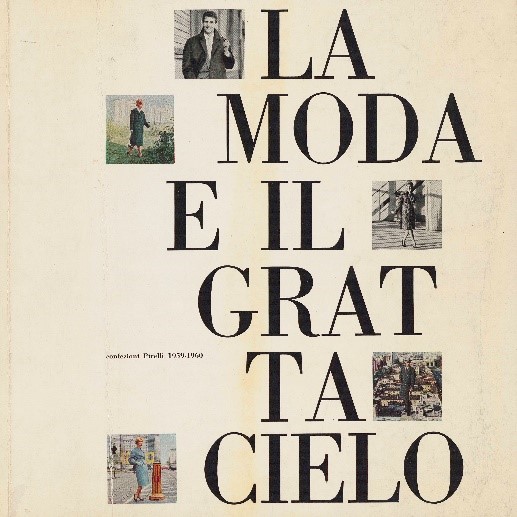Un viaggio tra i libri per capire la crisi di Milano e costruire risposte né giustizialiste né populiste
“Non esiste avere troppi libri, esiste solo non avere abbastanza scaffali”, dice la didascalia della bella foto d’una colonna di volumi, ricorrente su Fb (sarà merito d’un algoritmo amante della letteratura e dei lettori). E in questI giorni così densi di incertezze, sulle caratteristiche e sul futuro di Milano, nel cuore di una nuova tempesta giudiziaria e mediatica, politica e amministrativa, vale proprio la pena uscire per un momento dai percorsi delle cronache, ricorrere piuttosto ai libri e cercare, tra le loro pagine sapide e argute, utili stimoli di riflessione critica, seguendo le suggestioni di Alberto Manguel (“Vivere con i libri”, Einaudi) nel viaggio all’interno della sua biblioteca.
Prendiamo “Le città invisibili” di Italo Calvino, innanzitutto. E andiamo alla pagina conclusiva del dialogo tra il potente Kublai Khan e il saggio Marco Polo, su come affrontare “l’inferno dei viventi” e cioè “l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme”. Sostiene Calvino, dando la parola a Marco Polo: “Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio”.
Un’indicazione di metodo, dunque. Con una solida connotazione etica: nessuna rassegnazione al degrado nella zona grigia dell’indifferenza, ma semmai un impegno a capire e scegliere come agire. Affrontare dunque la crisi (nella radice della parola, dal verbo greco krino e cioè distinguere, separare, giudicare, c’è il suo profondo significato) valutandone fratture e vie d’uscita, pericoli e opportunità. Farsi carico di un “rischio” (è la parola che usa Calvino) nel dare spazio e tempo a ciò che “non è inferno”. Affrontare una sfida che oggi, a Milano, è politica e culturale, di progetto di città come comunità in movimento lungo i controversi e conflittuali percorsi della modernità. E dunque costruire un migliore futuro, meno squilibrato, più socialmente accettabile.
Milano è città riformista, nel profondo della sua cultura politica (lo testimoniano le esperienze politicamente trasversali dei suoi sindaci, dal socialista Antonio Greppi nella ricostruzione dell’immediato dopoguerra a Carlo Tognoli nei dinamici Anni Ottanta, dai primi cittadini di centro destra Luigi Albertini e Letizia Moratti a quelli di centro sinistra Giuliano Pisapia e adesso Beppe Sala). Dinamica. Produttiva. Ma anche sensibile alle dimensioni sociali. E inclusiva. Animata dall’ansia del “fare”. E contemporaneamente dal senso di responsabilità del “fare bene”. E dal solidarismo del “fare del bene”. Spirito civile da cittadini e certo non da frettolosi city users incuranti del buon destino della comunità. Dimensioni economiche ed etiche che riguardano anche le sue imprese, nella storia e nell’attualità.
Sugli scaffali della biblioteca di casa, è facile ritrovare le pagine medioevali di Bonvesin della Riva (“Le meraviglie di Milano”, tutt’altro che limitate alle architetture) e quelle del vescovo Ariberto d’Intimiano (“Chi sa lavorare venga a Milano. E chi viene a Milano è un uomo libero”, il lavoro come identità e cittadinanza, la città aperta, il senso del cambiamento e del progresso, avvenuto nel cuore dei tempi del potere feudale e delle corporazioni). La riproduzione dei disegni tecnici di Leonardo da Vinci per le “macchine” e gli ingranaggi d’una città ingegnosa e operosa (gli originali stanno nelle tavole del “Codice Atlantico” all’Ambrosiana). La lucidità civile de “Il Caffè” dei Verri e degli altri illuministi milanesi, attenti al “buon governo” e alla relazione tra diritti e doveri, leggi e giustizia, con le indicazioni di Cesare Beccaria. E ancora l’intelligenza economica di Carlo Cattaneo. La letteratura connotata da un forte senso morale di Alessandro Manzoni. E quell’idea diffusa di progresso e di civiltà, di convivenza sociale e di sviluppo, di dolore del vivere e di speranze da coltivare, di spirito di comunità e passione per la competitività (le due parole hanno un cum d’origine che le tiene insieme, in modo originale): tutte dimensioni che nel tempo segnano le opere di Testori e Gadda, Vittorini e Buzzati, Bianciardi e, perché no? Scerbanenco. Le luci e le ombre, la società civile e le marginalità sociali, sino agli spazi occupati dalla criminalità (per averne idea, basta leggere “Elementi di urbanistica noir” di Gianni Biondillo, architetto e scrittore, edito da EuroMilano).
Gli scaffali, insomma, sono particolarmente carichi di intelligenza e sapienza, per non dire dei romanzi e dei saggi di più stretta attualità. Perché “hai voglia a dire Milano, Milano. Hai voglia a scrivere Milano, Milano…”, per usare i giochi verbali di Aldo Nove sulla difficile e controversa rappresentazione della città, come fosse un iceberg, in “Milano non è Milano” (Laterza).
Cosa emerge, da questo viaggio intellettuale e, in fin dei conti, anche sentimentale (le città hanno un’anima, esercitano un fascino su chi le vive o anche solo le frequenta e le osserva, sono in grado di fare innamorare) lungo le pareti d’una casa piena di libri? L’idea forte d’una Milano molteplice, plurale, anche contraddittoria (infatti “contiene moltitudini”, per prendere in prestito le sapienti parole di Walt Whitman, amato da Vittorini) e comunque attenta alla dimensione di una “città che sale” (utile, riguardare la pittura di Boccioni). La consapevolezza della storia come percorso tutt’altro che lineare, ma semmai accidentato. Di un “corso delle cose sinuoso”, alla Merleau-Ponty. E di una volontà forte, in ogni caso, di uscire dalle crisi che nella storia sono ricorrenti. Riconoscere dunque le caratteristiche dell’inferno e averne ragione. Ben sapendo che, uscendone, non c’è il paradiso. Ma la possibilità di una Milano migliore, finché una nuova stagione di cambiamenti non imponga di definire e costruire altri assetti e inediti equilibri.
Ci sono altre pagine, con cui fare i conti. Sono quelle di Stendhal, tanto appassionatamente legato a Milano da volere che nel suo epitaffio, al cimitero di Montmartre, ci fosse scritto “milanese”. E affascinato dalla convivenza, in città, di teatro e moda, commercio e belle architetture, ricchezze eleganti e vivacità popolare (“questo popolo nato per il bello…”), intraprendenza e desiderio di “costruire una casa o se non altro rinnovare la facciata di quella ereditata dal padre”.
Di questa tendenza, che lega successo economico a decoro urbano, ricchezza ad architettura, si ritrovano testimonianze esemplari nelle immagini di Nicolò Biddau ne “I cortili di Milano”, Photo Publisher (“Le corti di Milano sono scenografie silenziose di un teatro antico, dove ogni pietra e ogni dettaglio raccontano una storia nascosta”) e in “Case milanesi” di Orsina Simona Pierini e Alessandro Isastia, Hoepli. La bellezza e il dinamismo del costruire.
Stendhal, insomma, vedeva bene le caratteristiche della sua contemporaneità e coltivava uno sguardo capace di legare l’attualità alle tendenze future. Le sue osservazioni si ritrovano, adesso, nelle considerazioni di Carlo Ratti, architetto, una vita universitaria e scientifica tra Torino e il Mit di Boston, la cura della 19° Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia e un assiduo impegno professionale sui temi della Smart City (con il suo studio CRA – Carlo Ratti e Associati lavora al masterplan dell’area milanese di Porta Romana). “Milano – sostiene su La Stampa (18 luglio) – non ha mai avuto un’anima contemplativa. E’ sempre stata mercantile, pragmatica, abituata a coniugare affari e cultura. Come raccontava, appunto, anche Stendhal. È una città di successo. La porta d’ingresso dell’Italia verso l’economia globale. Ciò che la mia collega Saskia Sassen chiama una global city. E questa condizione non è certo qualcosa di cui scusarsi. Il punto, adesso, non è eliminare lo spettacolo della modernità, ma assicurarsi che esista ancora il backstage: per studenti, migranti, innovatori, per chi prova e sbaglia”.
Milano, insomma, con i grattacieli, la finanza, la moda, gli eventi glamour, fa i conti con le tendenze internazionali. Da vivere. E però pure da governare. Insiste Ratti: “Il tema è il successo: quando una città funziona, attira persone e capitali, i prezzi salgono e l’inclusione rischia di diventare esclusione. Credo che nei prossimi anni vedremo correttivi: più edilizia accessibile, più strumenti per contenere la gentrificazione”.
Sono stati “anni di corsa”. La città è stata “un laboratorio”. E adesso, sostiene ancora Ratti (Il Giorno, 20 luglio), “bisogna evitare che si creino bolle speculative. Usando strumenti efficaci per garantire l’equilibrio della civitas, della comunità cittadina. Incentivi per costruire di più se si destinano quote di alloggi a prezzi convenzionati. Un modo per bilanciare crescita e inclusività”.
È vero, infatti, che Milano è tra le prime dieci città del mondo “in cui vogliono vivere i grandi ricchi”, dopo Singapore, Londra, Hong Kong, Monaco, Zurigo, Parigi e prima di Francoforte e Barcellona (secondo il Global Report Julius Baer, Il Sole24ore, 15 luglio): un primato a molte facce. Ma è altrettanto vero che Milano, diventando città esclusiva per ricchi del mondo, perderebbe la sua anima, metterebbe ai margini ceti medi, giovani, nuovi imprenditori ancora non arrivati al successo economico, intellettuali, creativi, persone comuni, gente seria e laboriosa. Avrebbe ristoranti e negozi di lusso. Ma non libri. Né cultura critica. Né dunque coscienza civile.
Sugli scaffali, andiamo allora a cercare altri libri per capire e ragionare: “Milanesi si diventa”, di Carlo Castellaneta (Mondadori, 1991), un romanzo sulle capacità di accoglienza di una città severa e comunque inclusiva, generosa di opportunità. E “Sulla formazione della classe dirigente – L’ultimo progetto di Raffaele Mattioli”, a cura di Francesca Pino (Aragno, 2023), una raccolta di saggi sul ruolo di un grande banchiere e mecenate, guida della Banca Commerciale Italiana dai primi anni Trenta agli anni Sessanta del Novecento, uno dei protagonisti della ricostruzione e poi del boom economico italiano, come racconta anche Elena Grazioli in “Raffaele Mattioli oltre la banca. Ritratto pubblico e privato di un grande intellettuale”, Luni Editrice. Era abruzzese d’origine, Mattioli. E profondamente milanese nello stile economico e nella cultura umanistica e finanziaria. In sintesi: una finanza per l’impresa e soprattutto l’industria, non per gli speculatori e per chi vuole “fare soldi per mezzo dei soldi”.
Cosa ci dicono questi libri (e i tanti altri che potremmo consultare e citare)? Che Milano, nel suo dinamismo e nell’ansia di fare e di reggere il passo con il cambiamento e l’innovazione, se non talvolta addirittura di anticiparne tempi e modi, soffre l’imbrigliamento di regole formali e burocrazie. Città intraprendente, invece che attardarsi sulle procedure, punta ai risultati.
Oggi, senza naturalmente entrare nel merito delle indagini giudiziarie in corso (notando comunque che non sembra si sia di fronte a una “nuova Tangentopoli”: lo sostengono Michele Serra su la Repubblica e Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, 20 luglio), vale la pena affrontare la crisi senza limitarsi alle cronache e alle schermaglie della propaganda politica. E andare invece, nel necessario dibattito pubblico, al nodo dei problemi.
L’orgoglio di Milano produttiva da giocare in positivo. Le ferite sociali della metropoli da ricucire. La crescita da governare. Ma anche le leggi da riscrivere, superando lo stallo imposto da “un labirinto di regole, spesso opache e contraddittorie” (definizione di Carlo Ratti), scritte a metà del Novecento (quando altri erano i bisogni urbanistici, altri gli interessi, la finanza, le imprese). La pubblica amministrazione da rendere efficiente ed efficace, lavorando per risultati e non per procedure. Gli squilibri da capire, affrontare, provare a risolvere. I servizi pubblici e i beni comuni da garantire. Essere civitas.
Compiti da “classe dirigente”, appunto. E da coscienza civile avvertita e capace di discutere seriamente sul futuro.
Milano, infatti, lo merita. Senza farsi abbagliare dalle “mille luci”, dall’avidità delle rendite e dall’effimero degli eventi, ma nemmeno dal giustizialismo populista e dalle tentazioni della “decrescita”, comunque infelice.
Il giro degli scaffali della biblioteca racconta proprio questo: l’anima robusta e sensibile d’una grande città, che chiede di continuare a crescere, produttiva e inclusiva, innovativa e solidale, com’è sempre stata.






“Non esiste avere troppi libri, esiste solo non avere abbastanza scaffali”, dice la didascalia della bella foto d’una colonna di volumi, ricorrente su Fb (sarà merito d’un algoritmo amante della letteratura e dei lettori). E in questI giorni così densi di incertezze, sulle caratteristiche e sul futuro di Milano, nel cuore di una nuova tempesta giudiziaria e mediatica, politica e amministrativa, vale proprio la pena uscire per un momento dai percorsi delle cronache, ricorrere piuttosto ai libri e cercare, tra le loro pagine sapide e argute, utili stimoli di riflessione critica, seguendo le suggestioni di Alberto Manguel (“Vivere con i libri”, Einaudi) nel viaggio all’interno della sua biblioteca.
Prendiamo “Le città invisibili” di Italo Calvino, innanzitutto. E andiamo alla pagina conclusiva del dialogo tra il potente Kublai Khan e il saggio Marco Polo, su come affrontare “l’inferno dei viventi” e cioè “l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme”. Sostiene Calvino, dando la parola a Marco Polo: “Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio”.
Un’indicazione di metodo, dunque. Con una solida connotazione etica: nessuna rassegnazione al degrado nella zona grigia dell’indifferenza, ma semmai un impegno a capire e scegliere come agire. Affrontare dunque la crisi (nella radice della parola, dal verbo greco krino e cioè distinguere, separare, giudicare, c’è il suo profondo significato) valutandone fratture e vie d’uscita, pericoli e opportunità. Farsi carico di un “rischio” (è la parola che usa Calvino) nel dare spazio e tempo a ciò che “non è inferno”. Affrontare una sfida che oggi, a Milano, è politica e culturale, di progetto di città come comunità in movimento lungo i controversi e conflittuali percorsi della modernità. E dunque costruire un migliore futuro, meno squilibrato, più socialmente accettabile.
Milano è città riformista, nel profondo della sua cultura politica (lo testimoniano le esperienze politicamente trasversali dei suoi sindaci, dal socialista Antonio Greppi nella ricostruzione dell’immediato dopoguerra a Carlo Tognoli nei dinamici Anni Ottanta, dai primi cittadini di centro destra Luigi Albertini e Letizia Moratti a quelli di centro sinistra Giuliano Pisapia e adesso Beppe Sala). Dinamica. Produttiva. Ma anche sensibile alle dimensioni sociali. E inclusiva. Animata dall’ansia del “fare”. E contemporaneamente dal senso di responsabilità del “fare bene”. E dal solidarismo del “fare del bene”. Spirito civile da cittadini e certo non da frettolosi city users incuranti del buon destino della comunità. Dimensioni economiche ed etiche che riguardano anche le sue imprese, nella storia e nell’attualità.
Sugli scaffali della biblioteca di casa, è facile ritrovare le pagine medioevali di Bonvesin della Riva (“Le meraviglie di Milano”, tutt’altro che limitate alle architetture) e quelle del vescovo Ariberto d’Intimiano (“Chi sa lavorare venga a Milano. E chi viene a Milano è un uomo libero”, il lavoro come identità e cittadinanza, la città aperta, il senso del cambiamento e del progresso, avvenuto nel cuore dei tempi del potere feudale e delle corporazioni). La riproduzione dei disegni tecnici di Leonardo da Vinci per le “macchine” e gli ingranaggi d’una città ingegnosa e operosa (gli originali stanno nelle tavole del “Codice Atlantico” all’Ambrosiana). La lucidità civile de “Il Caffè” dei Verri e degli altri illuministi milanesi, attenti al “buon governo” e alla relazione tra diritti e doveri, leggi e giustizia, con le indicazioni di Cesare Beccaria. E ancora l’intelligenza economica di Carlo Cattaneo. La letteratura connotata da un forte senso morale di Alessandro Manzoni. E quell’idea diffusa di progresso e di civiltà, di convivenza sociale e di sviluppo, di dolore del vivere e di speranze da coltivare, di spirito di comunità e passione per la competitività (le due parole hanno un cum d’origine che le tiene insieme, in modo originale): tutte dimensioni che nel tempo segnano le opere di Testori e Gadda, Vittorini e Buzzati, Bianciardi e, perché no? Scerbanenco. Le luci e le ombre, la società civile e le marginalità sociali, sino agli spazi occupati dalla criminalità (per averne idea, basta leggere “Elementi di urbanistica noir” di Gianni Biondillo, architetto e scrittore, edito da EuroMilano).
Gli scaffali, insomma, sono particolarmente carichi di intelligenza e sapienza, per non dire dei romanzi e dei saggi di più stretta attualità. Perché “hai voglia a dire Milano, Milano. Hai voglia a scrivere Milano, Milano…”, per usare i giochi verbali di Aldo Nove sulla difficile e controversa rappresentazione della città, come fosse un iceberg, in “Milano non è Milano” (Laterza).
Cosa emerge, da questo viaggio intellettuale e, in fin dei conti, anche sentimentale (le città hanno un’anima, esercitano un fascino su chi le vive o anche solo le frequenta e le osserva, sono in grado di fare innamorare) lungo le pareti d’una casa piena di libri? L’idea forte d’una Milano molteplice, plurale, anche contraddittoria (infatti “contiene moltitudini”, per prendere in prestito le sapienti parole di Walt Whitman, amato da Vittorini) e comunque attenta alla dimensione di una “città che sale” (utile, riguardare la pittura di Boccioni). La consapevolezza della storia come percorso tutt’altro che lineare, ma semmai accidentato. Di un “corso delle cose sinuoso”, alla Merleau-Ponty. E di una volontà forte, in ogni caso, di uscire dalle crisi che nella storia sono ricorrenti. Riconoscere dunque le caratteristiche dell’inferno e averne ragione. Ben sapendo che, uscendone, non c’è il paradiso. Ma la possibilità di una Milano migliore, finché una nuova stagione di cambiamenti non imponga di definire e costruire altri assetti e inediti equilibri.
Ci sono altre pagine, con cui fare i conti. Sono quelle di Stendhal, tanto appassionatamente legato a Milano da volere che nel suo epitaffio, al cimitero di Montmartre, ci fosse scritto “milanese”. E affascinato dalla convivenza, in città, di teatro e moda, commercio e belle architetture, ricchezze eleganti e vivacità popolare (“questo popolo nato per il bello…”), intraprendenza e desiderio di “costruire una casa o se non altro rinnovare la facciata di quella ereditata dal padre”.
Di questa tendenza, che lega successo economico a decoro urbano, ricchezza ad architettura, si ritrovano testimonianze esemplari nelle immagini di Nicolò Biddau ne “I cortili di Milano”, Photo Publisher (“Le corti di Milano sono scenografie silenziose di un teatro antico, dove ogni pietra e ogni dettaglio raccontano una storia nascosta”) e in “Case milanesi” di Orsina Simona Pierini e Alessandro Isastia, Hoepli. La bellezza e il dinamismo del costruire.
Stendhal, insomma, vedeva bene le caratteristiche della sua contemporaneità e coltivava uno sguardo capace di legare l’attualità alle tendenze future. Le sue osservazioni si ritrovano, adesso, nelle considerazioni di Carlo Ratti, architetto, una vita universitaria e scientifica tra Torino e il Mit di Boston, la cura della 19° Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia e un assiduo impegno professionale sui temi della Smart City (con il suo studio CRA – Carlo Ratti e Associati lavora al masterplan dell’area milanese di Porta Romana). “Milano – sostiene su La Stampa (18 luglio) – non ha mai avuto un’anima contemplativa. E’ sempre stata mercantile, pragmatica, abituata a coniugare affari e cultura. Come raccontava, appunto, anche Stendhal. È una città di successo. La porta d’ingresso dell’Italia verso l’economia globale. Ciò che la mia collega Saskia Sassen chiama una global city. E questa condizione non è certo qualcosa di cui scusarsi. Il punto, adesso, non è eliminare lo spettacolo della modernità, ma assicurarsi che esista ancora il backstage: per studenti, migranti, innovatori, per chi prova e sbaglia”.
Milano, insomma, con i grattacieli, la finanza, la moda, gli eventi glamour, fa i conti con le tendenze internazionali. Da vivere. E però pure da governare. Insiste Ratti: “Il tema è il successo: quando una città funziona, attira persone e capitali, i prezzi salgono e l’inclusione rischia di diventare esclusione. Credo che nei prossimi anni vedremo correttivi: più edilizia accessibile, più strumenti per contenere la gentrificazione”.
Sono stati “anni di corsa”. La città è stata “un laboratorio”. E adesso, sostiene ancora Ratti (Il Giorno, 20 luglio), “bisogna evitare che si creino bolle speculative. Usando strumenti efficaci per garantire l’equilibrio della civitas, della comunità cittadina. Incentivi per costruire di più se si destinano quote di alloggi a prezzi convenzionati. Un modo per bilanciare crescita e inclusività”.
È vero, infatti, che Milano è tra le prime dieci città del mondo “in cui vogliono vivere i grandi ricchi”, dopo Singapore, Londra, Hong Kong, Monaco, Zurigo, Parigi e prima di Francoforte e Barcellona (secondo il Global Report Julius Baer, Il Sole24ore, 15 luglio): un primato a molte facce. Ma è altrettanto vero che Milano, diventando città esclusiva per ricchi del mondo, perderebbe la sua anima, metterebbe ai margini ceti medi, giovani, nuovi imprenditori ancora non arrivati al successo economico, intellettuali, creativi, persone comuni, gente seria e laboriosa. Avrebbe ristoranti e negozi di lusso. Ma non libri. Né cultura critica. Né dunque coscienza civile.
Sugli scaffali, andiamo allora a cercare altri libri per capire e ragionare: “Milanesi si diventa”, di Carlo Castellaneta (Mondadori, 1991), un romanzo sulle capacità di accoglienza di una città severa e comunque inclusiva, generosa di opportunità. E “Sulla formazione della classe dirigente – L’ultimo progetto di Raffaele Mattioli”, a cura di Francesca Pino (Aragno, 2023), una raccolta di saggi sul ruolo di un grande banchiere e mecenate, guida della Banca Commerciale Italiana dai primi anni Trenta agli anni Sessanta del Novecento, uno dei protagonisti della ricostruzione e poi del boom economico italiano, come racconta anche Elena Grazioli in “Raffaele Mattioli oltre la banca. Ritratto pubblico e privato di un grande intellettuale”, Luni Editrice. Era abruzzese d’origine, Mattioli. E profondamente milanese nello stile economico e nella cultura umanistica e finanziaria. In sintesi: una finanza per l’impresa e soprattutto l’industria, non per gli speculatori e per chi vuole “fare soldi per mezzo dei soldi”.
Cosa ci dicono questi libri (e i tanti altri che potremmo consultare e citare)? Che Milano, nel suo dinamismo e nell’ansia di fare e di reggere il passo con il cambiamento e l’innovazione, se non talvolta addirittura di anticiparne tempi e modi, soffre l’imbrigliamento di regole formali e burocrazie. Città intraprendente, invece che attardarsi sulle procedure, punta ai risultati.
Oggi, senza naturalmente entrare nel merito delle indagini giudiziarie in corso (notando comunque che non sembra si sia di fronte a una “nuova Tangentopoli”: lo sostengono Michele Serra su la Repubblica e Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, 20 luglio), vale la pena affrontare la crisi senza limitarsi alle cronache e alle schermaglie della propaganda politica. E andare invece, nel necessario dibattito pubblico, al nodo dei problemi.
L’orgoglio di Milano produttiva da giocare in positivo. Le ferite sociali della metropoli da ricucire. La crescita da governare. Ma anche le leggi da riscrivere, superando lo stallo imposto da “un labirinto di regole, spesso opache e contraddittorie” (definizione di Carlo Ratti), scritte a metà del Novecento (quando altri erano i bisogni urbanistici, altri gli interessi, la finanza, le imprese). La pubblica amministrazione da rendere efficiente ed efficace, lavorando per risultati e non per procedure. Gli squilibri da capire, affrontare, provare a risolvere. I servizi pubblici e i beni comuni da garantire. Essere civitas.
Compiti da “classe dirigente”, appunto. E da coscienza civile avvertita e capace di discutere seriamente sul futuro.
Milano, infatti, lo merita. Senza farsi abbagliare dalle “mille luci”, dall’avidità delle rendite e dall’effimero degli eventi, ma nemmeno dal giustizialismo populista e dalle tentazioni della “decrescita”, comunque infelice.
Il giro degli scaffali della biblioteca racconta proprio questo: l’anima robusta e sensibile d’una grande città, che chiede di continuare a crescere, produttiva e inclusiva, innovativa e solidale, com’è sempre stata.