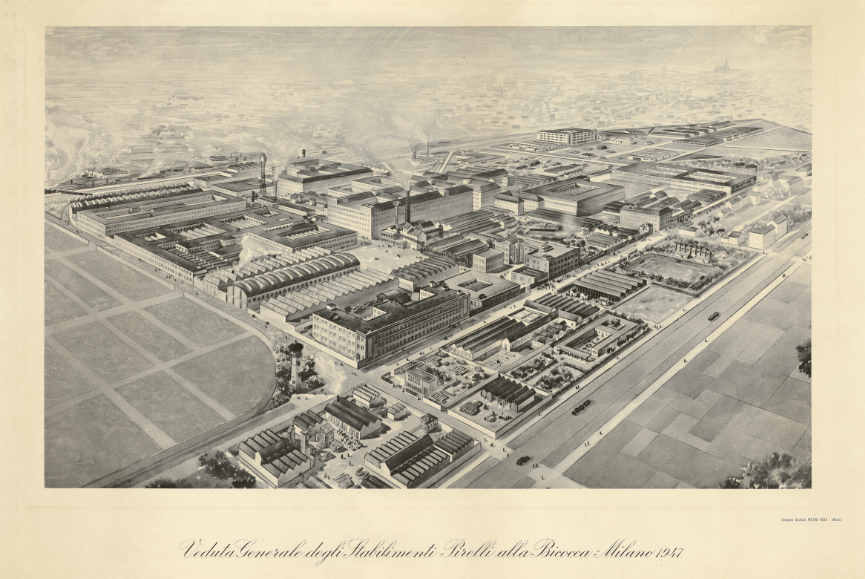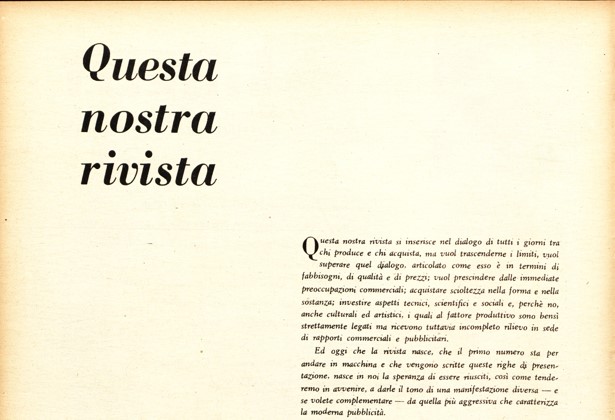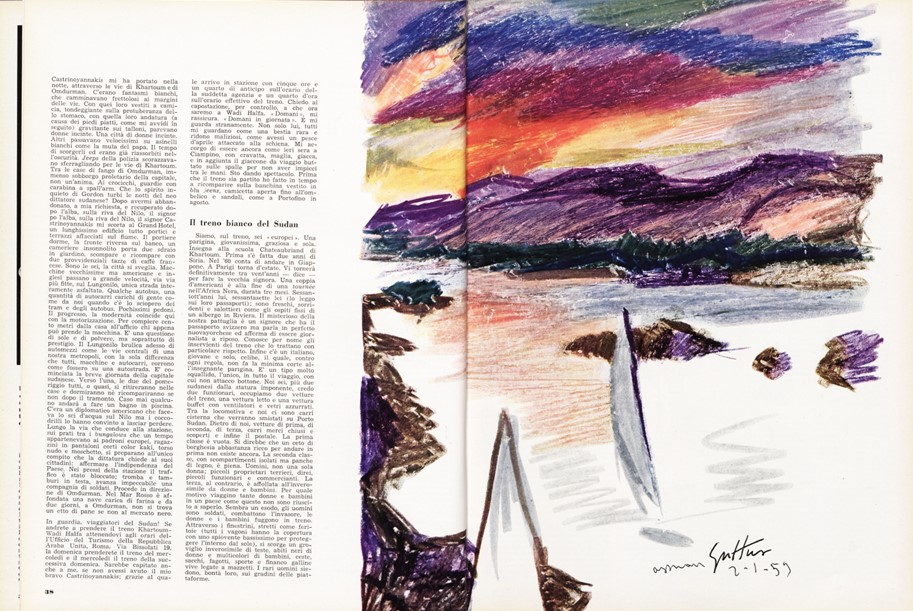Il ragazzo scrivano di Raffaello e il bisogno di cultura critica contro il mito di Narciso
Un vento impetuoso gli scompiglia i capelli. Ma non ne turba la concentrazione. Sta in piedi, appoggiato al muro, con le gambe intrecciate, per tenersi meglio in equilibrio. E scrive, con il volto chino sul quaderno poggiato al di sopra del ginocchio e la penna ben salda nella mano, per dare alle parole e forse ai disegni tutta l’attenzione che meritano.
È poco più che un ragazzo, uno studente o un giovane di bottega, un aspirante artista o scienziato. E sembra incurante del mondo che gli sta attorno. Eppure quello che lo circonda è un mondo solenne. Filosofi, matematici, scienziati. Una sintesi della conoscenza. Una metafora della sapienza. Con l’uomo al centro.
Ecco “La scuola di Atene”, il grande affresco dipinto da Raffaello all’inizio del Cinquecento nella Stanza della Segnatura, una delle quattro “Stanze Vaticane” all’interno dei Palazzi Apostolici (il cartone preparatorio, affascinante come le migliori testimonianze della creatività in fieri, domina una delle sale più importanti dell’Ambrosiana di Milano). Un capolavoro del Rinascimento, simbolo di un mondo che affonda le sue radici nella grande cultura classica e dunque può ambire a prefigurare un miglior futuro di bellezza e ragione. Un “tempio della Filosofia”, per rifarsi a un’idea di Marsilio Ficino, sapiente interprete dell’Umanesimo.
Al centro, alla sommità di un’ampia scalinata, ci sono Aristotele e Platone. Tutt’attorno, i discepoli, reali o ideali. Intenti a discutere di astronomia e geometria, degli spazi celesti e del turbinio delle idee. Ci sono, tra i personaggi, Zenone ed Epicuro, Euclide o forse Archimede. Ma anche due figure d’attualità. Michelangelo, un po’ separato dai gruppi, pensoso e distratto dal disegno che sta abbozzando, solitario, ombroso (com’era per attitudine e carattere, un maestro infastidito dai suoi contemporanei e dagli stessi allievi). E Raffaello, che dall’alto, quasi di profilo, si compiace di tale e tanta adunata d’intelletti (lui stesso, dunque, un “maestro” in quell’adunata). Polemiche tra artisti. Ma anche rappresentazione di diverse concezioni della vita e dell’arte. Tra il tormento e il sublime.
E quel ragazzo nervoso, che scrive nel vento? Nulla si sa di lui. Né Vasari né altri critici e storici, nel corso del tempo, si sono mai posti il problema di chi fosse e del perché proprio tra i suoi capelli s’insinuasse un soffio d’aria potente.
Il corso delle cose, però, è sinuoso. E quel ragazzo scrivano viene prelevato di peso dall’affresco di Raffaello e promosso dai Guns N’ Roses a personaggio centrale, isolato sulle due copertine, una in giallo-rosso e l’altra in azzurro-viola, di “Use Your Illusion”, il doppio album del settembre 1991 che ospita, tra gli altri brani (come le famose “Don’t cry” e “Live and let die”), una delle più intense versioni di “Knockin’ On Heaven’s Door”, la struggente canzone scritta nel 1973 da Bob Dylan per la colonna sonora di “Pat Garrett e Billy Kid” di Sam Peckinpah, l’elegia della morte dello sceriffo Baker, un uomo buono, tutt’altro che lo stereotipo d’un eroe western. Uno come tanti di noi, travolti dalla storia.
Saper fare buon uso delle proprie illusioni. E, mentre il sole della vita tramonta, bussare alle porte del Paradiso, in cerca di pace. Proprio quella pace che i nostri tempi così incerti e controversi non sembrano proprio concederci. Nonostante le promesse umanistiche del dominio saggio della Conoscenza. E le successive speranze illuministe del trionfo della Ragione.
E così, quel ragazzo di Raffaello riportato a nuova vita dai Guns N’ Roses oggi, come allora, ci parla d’inquietudine. E di un mai tramontato bisogno di segni in cui tradurla e provare a placarla. Di dipinti. Di parole sapienti.
Il gioco tra la pittura rinascimentale e il grande rock contemporaneo affiora dalla conversazione di un acuto banchiere, Ugo Loeser, Ceo di Arca Fondi. E l’occasione è la presentazione di un sapiente, essenziale libro di Patrizia Fontana, “Dai forma al tuo talento” (Franco Angeli Editore), un “racconto di viaggio” tra i problemi e le speranze delle nuove generazioni in cerca di realizzazione, personale oltre che professionale.
Un sondaggio condotto tra gennaio e febbraio ‘25 da “Talent in Motion” su 1.600 giovani adulti (dai 20 ai 30 anni, per l’86% in possesso di laurea) mostra che l’80% degli intervistati ha “paura del fallimento”, di “deludere se stessi” e “gli altri”. Quasi tutti considerano “significativo” “il successo” (85%) ma temono di “sbagliare le scelte lavorative” (75%) e in ogni caso il 78% confessa di non sapere come muoversi “nell’attuale contesto di incertezza lavorativa”. In ogni caso, il 76% “prova ansia di fronte alla competizione”.
Una generazione in drammatica crisi di fiducia. In costante condizione di acuta preoccupazione per l’incrocio inquietante tra tensioni geopolitiche ed economiche generali e scarsa affidabilità nelle proprie capacità, nel buon uso dei propri “talenti”.
Tanta incertezza mina le possibilità di costruzione del futuro. Il senso di comunità. Le fondamenta stesse dell’economia di mercato e della democrazia liberale. E pretende risposte.
Da questo punto di vista, la parola “talento” usata da Patrizia Fontana non può non rinviare all’omonima parabola evangelica, all’intelligenza progettuale e realizzativa dei servi che, invece di mettere la moneta avuta dal padrone al riparo dai rischi, sotterrandola, la investono e la fanno fruttare. E se quel talento non è inteso soltanto in senso stretto, monetario, allora il riferimento della parabola assume una portata ancora più ampia, culturale e, perché no? etica. Indicando qualità personali e sociali da impiegare per superare timori e paure e dunque rafforzare il bene comune, i “beni pubblici”, gli interessi generali.
Come? Oltre che guardare dentro di sé, è necessario imparare a valutare i contesti in cui le proprie scelte si inseriscono, le condizioni in cui ci si troverà a operare. Studiare bene storia e geografia, politica ed economia, situazioni sociali e cambiamenti del panorama scientifico e tecnologico. In tempi di così radicali, rapide e impetuose mutazioni degli assetti dei mercati e, più in generale, degli equilibri socio-economici, occorre avere un’attitudine flessibile e spregiudicata (nel senso etimologico, dell’assenza di pregiudizi) allo studio e all’adattamento alle novità. Servono competenze, è vero. Ma soprattutto una robusta e ambiziosa inclinazione alla conoscenza. La cui base sta nel saper fare domande. Occorre “imparare a imparare”, suggeriscono i buoni maestri.
È necessario, insomma, contribuire a scrivere nuove mappe cognitive, seguendo proprio una strada già indicata con chiarezza, da tempo, dai protagonisti della cultura d’impresa: valorizzare una “cultura politecnica” che lega i saperi umanistici con le conoscenze scientifiche, il senso della bellezza così radicato nella cultura italiana con l’inclinazione all’intraprendenza originale e all’innovazione, l’importanza della consapevolezza storica con l’attitudine a pensare “storie al futuro”. Insistendo sull’ “avvenire della memoria”, memori comunque dell’avvertimento alla cautela di Leonardo Sciascia: “Se la memoria ha un futuro…”.
Una lezione da “umanesimo industriale”, dunque. Ed è proprio la struttura degli algoritmi, la costruzione dei meccanismi dell’Artificial Intelligence oramai molto diffusa, a dirci che c’è bisogno d’un impegno multidisciplinare (cyberscience, fisica, matematica, statistica, ingegneria ma anche sociologia, filosofia, psicologia, economia, diritto) per capirne senso e valori e governarne dinamiche e conseguenze.
Una cultura critica, dunque. Come orizzonte di conoscenza. E come indirizzo etico. Una riposta su cui insistere, proprio con le nuove generazioni. Con le ragazze e i ragazzi che continuano a porsi e a porre alle nostre generazioni di genitori e nonni domande di senso e di costruzione di valori.
È un obbligo, provare a dare risposte cariche di possibilità di fiducia nel futuro. Anche per evitare la trappola della caduta nel dominio di Narciso, mito negativo, simbolo di morte (il personaggio annega, nell’ammirarsi fatuo e fatale nello specchio d’acqua) e di nichilismo, tutto il contrario del bisogno diffuso di creatività, di comunità e, perché no?, di competitività (che – ricordiamolo – viene dal latino cum e petere, e cioè muoversi insieme verso un orizzonte condiviso). E per non ritrovarsi nemmeno preda di una vera e propria solitudine tecnologica, in cui si dialoga con l’AI pur di avere un confronto, senza rendersi conto d’essere di fronte non “allo sguardo dell’altro” in cui costruire la propria, pur problematica, identità, ma alla manipolazione d’un ingannevole specchio.
E così si torna all’inquietudine e alla scrittura salvifica del ragazzo di Raffaello. Raffigurazione d’ognuno di noi, del nostro onesto e sincero tentativo di delineare il nostro destino. Lasciando comunque che il vento gli scompigli e ci scompigli i capelli. E le idee. Ricordandosi ancora di Bob Dylan, “Blowin’ in the Wind”, appunto.
(foto: Getty Images)






Un vento impetuoso gli scompiglia i capelli. Ma non ne turba la concentrazione. Sta in piedi, appoggiato al muro, con le gambe intrecciate, per tenersi meglio in equilibrio. E scrive, con il volto chino sul quaderno poggiato al di sopra del ginocchio e la penna ben salda nella mano, per dare alle parole e forse ai disegni tutta l’attenzione che meritano.
È poco più che un ragazzo, uno studente o un giovane di bottega, un aspirante artista o scienziato. E sembra incurante del mondo che gli sta attorno. Eppure quello che lo circonda è un mondo solenne. Filosofi, matematici, scienziati. Una sintesi della conoscenza. Una metafora della sapienza. Con l’uomo al centro.
Ecco “La scuola di Atene”, il grande affresco dipinto da Raffaello all’inizio del Cinquecento nella Stanza della Segnatura, una delle quattro “Stanze Vaticane” all’interno dei Palazzi Apostolici (il cartone preparatorio, affascinante come le migliori testimonianze della creatività in fieri, domina una delle sale più importanti dell’Ambrosiana di Milano). Un capolavoro del Rinascimento, simbolo di un mondo che affonda le sue radici nella grande cultura classica e dunque può ambire a prefigurare un miglior futuro di bellezza e ragione. Un “tempio della Filosofia”, per rifarsi a un’idea di Marsilio Ficino, sapiente interprete dell’Umanesimo.
Al centro, alla sommità di un’ampia scalinata, ci sono Aristotele e Platone. Tutt’attorno, i discepoli, reali o ideali. Intenti a discutere di astronomia e geometria, degli spazi celesti e del turbinio delle idee. Ci sono, tra i personaggi, Zenone ed Epicuro, Euclide o forse Archimede. Ma anche due figure d’attualità. Michelangelo, un po’ separato dai gruppi, pensoso e distratto dal disegno che sta abbozzando, solitario, ombroso (com’era per attitudine e carattere, un maestro infastidito dai suoi contemporanei e dagli stessi allievi). E Raffaello, che dall’alto, quasi di profilo, si compiace di tale e tanta adunata d’intelletti (lui stesso, dunque, un “maestro” in quell’adunata). Polemiche tra artisti. Ma anche rappresentazione di diverse concezioni della vita e dell’arte. Tra il tormento e il sublime.
E quel ragazzo nervoso, che scrive nel vento? Nulla si sa di lui. Né Vasari né altri critici e storici, nel corso del tempo, si sono mai posti il problema di chi fosse e del perché proprio tra i suoi capelli s’insinuasse un soffio d’aria potente.
Il corso delle cose, però, è sinuoso. E quel ragazzo scrivano viene prelevato di peso dall’affresco di Raffaello e promosso dai Guns N’ Roses a personaggio centrale, isolato sulle due copertine, una in giallo-rosso e l’altra in azzurro-viola, di “Use Your Illusion”, il doppio album del settembre 1991 che ospita, tra gli altri brani (come le famose “Don’t cry” e “Live and let die”), una delle più intense versioni di “Knockin’ On Heaven’s Door”, la struggente canzone scritta nel 1973 da Bob Dylan per la colonna sonora di “Pat Garrett e Billy Kid” di Sam Peckinpah, l’elegia della morte dello sceriffo Baker, un uomo buono, tutt’altro che lo stereotipo d’un eroe western. Uno come tanti di noi, travolti dalla storia.
Saper fare buon uso delle proprie illusioni. E, mentre il sole della vita tramonta, bussare alle porte del Paradiso, in cerca di pace. Proprio quella pace che i nostri tempi così incerti e controversi non sembrano proprio concederci. Nonostante le promesse umanistiche del dominio saggio della Conoscenza. E le successive speranze illuministe del trionfo della Ragione.
E così, quel ragazzo di Raffaello riportato a nuova vita dai Guns N’ Roses oggi, come allora, ci parla d’inquietudine. E di un mai tramontato bisogno di segni in cui tradurla e provare a placarla. Di dipinti. Di parole sapienti.
Il gioco tra la pittura rinascimentale e il grande rock contemporaneo affiora dalla conversazione di un acuto banchiere, Ugo Loeser, Ceo di Arca Fondi. E l’occasione è la presentazione di un sapiente, essenziale libro di Patrizia Fontana, “Dai forma al tuo talento” (Franco Angeli Editore), un “racconto di viaggio” tra i problemi e le speranze delle nuove generazioni in cerca di realizzazione, personale oltre che professionale.
Un sondaggio condotto tra gennaio e febbraio ‘25 da “Talent in Motion” su 1.600 giovani adulti (dai 20 ai 30 anni, per l’86% in possesso di laurea) mostra che l’80% degli intervistati ha “paura del fallimento”, di “deludere se stessi” e “gli altri”. Quasi tutti considerano “significativo” “il successo” (85%) ma temono di “sbagliare le scelte lavorative” (75%) e in ogni caso il 78% confessa di non sapere come muoversi “nell’attuale contesto di incertezza lavorativa”. In ogni caso, il 76% “prova ansia di fronte alla competizione”.
Una generazione in drammatica crisi di fiducia. In costante condizione di acuta preoccupazione per l’incrocio inquietante tra tensioni geopolitiche ed economiche generali e scarsa affidabilità nelle proprie capacità, nel buon uso dei propri “talenti”.
Tanta incertezza mina le possibilità di costruzione del futuro. Il senso di comunità. Le fondamenta stesse dell’economia di mercato e della democrazia liberale. E pretende risposte.
Da questo punto di vista, la parola “talento” usata da Patrizia Fontana non può non rinviare all’omonima parabola evangelica, all’intelligenza progettuale e realizzativa dei servi che, invece di mettere la moneta avuta dal padrone al riparo dai rischi, sotterrandola, la investono e la fanno fruttare. E se quel talento non è inteso soltanto in senso stretto, monetario, allora il riferimento della parabola assume una portata ancora più ampia, culturale e, perché no? etica. Indicando qualità personali e sociali da impiegare per superare timori e paure e dunque rafforzare il bene comune, i “beni pubblici”, gli interessi generali.
Come? Oltre che guardare dentro di sé, è necessario imparare a valutare i contesti in cui le proprie scelte si inseriscono, le condizioni in cui ci si troverà a operare. Studiare bene storia e geografia, politica ed economia, situazioni sociali e cambiamenti del panorama scientifico e tecnologico. In tempi di così radicali, rapide e impetuose mutazioni degli assetti dei mercati e, più in generale, degli equilibri socio-economici, occorre avere un’attitudine flessibile e spregiudicata (nel senso etimologico, dell’assenza di pregiudizi) allo studio e all’adattamento alle novità. Servono competenze, è vero. Ma soprattutto una robusta e ambiziosa inclinazione alla conoscenza. La cui base sta nel saper fare domande. Occorre “imparare a imparare”, suggeriscono i buoni maestri.
È necessario, insomma, contribuire a scrivere nuove mappe cognitive, seguendo proprio una strada già indicata con chiarezza, da tempo, dai protagonisti della cultura d’impresa: valorizzare una “cultura politecnica” che lega i saperi umanistici con le conoscenze scientifiche, il senso della bellezza così radicato nella cultura italiana con l’inclinazione all’intraprendenza originale e all’innovazione, l’importanza della consapevolezza storica con l’attitudine a pensare “storie al futuro”. Insistendo sull’ “avvenire della memoria”, memori comunque dell’avvertimento alla cautela di Leonardo Sciascia: “Se la memoria ha un futuro…”.
Una lezione da “umanesimo industriale”, dunque. Ed è proprio la struttura degli algoritmi, la costruzione dei meccanismi dell’Artificial Intelligence oramai molto diffusa, a dirci che c’è bisogno d’un impegno multidisciplinare (cyberscience, fisica, matematica, statistica, ingegneria ma anche sociologia, filosofia, psicologia, economia, diritto) per capirne senso e valori e governarne dinamiche e conseguenze.
Una cultura critica, dunque. Come orizzonte di conoscenza. E come indirizzo etico. Una riposta su cui insistere, proprio con le nuove generazioni. Con le ragazze e i ragazzi che continuano a porsi e a porre alle nostre generazioni di genitori e nonni domande di senso e di costruzione di valori.
È un obbligo, provare a dare risposte cariche di possibilità di fiducia nel futuro. Anche per evitare la trappola della caduta nel dominio di Narciso, mito negativo, simbolo di morte (il personaggio annega, nell’ammirarsi fatuo e fatale nello specchio d’acqua) e di nichilismo, tutto il contrario del bisogno diffuso di creatività, di comunità e, perché no?, di competitività (che – ricordiamolo – viene dal latino cum e petere, e cioè muoversi insieme verso un orizzonte condiviso). E per non ritrovarsi nemmeno preda di una vera e propria solitudine tecnologica, in cui si dialoga con l’AI pur di avere un confronto, senza rendersi conto d’essere di fronte non “allo sguardo dell’altro” in cui costruire la propria, pur problematica, identità, ma alla manipolazione d’un ingannevole specchio.
E così si torna all’inquietudine e alla scrittura salvifica del ragazzo di Raffaello. Raffigurazione d’ognuno di noi, del nostro onesto e sincero tentativo di delineare il nostro destino. Lasciando comunque che il vento gli scompigli e ci scompigli i capelli. E le idee. Ricordandosi ancora di Bob Dylan, “Blowin’ in the Wind”, appunto.
(foto: Getty Images)